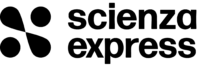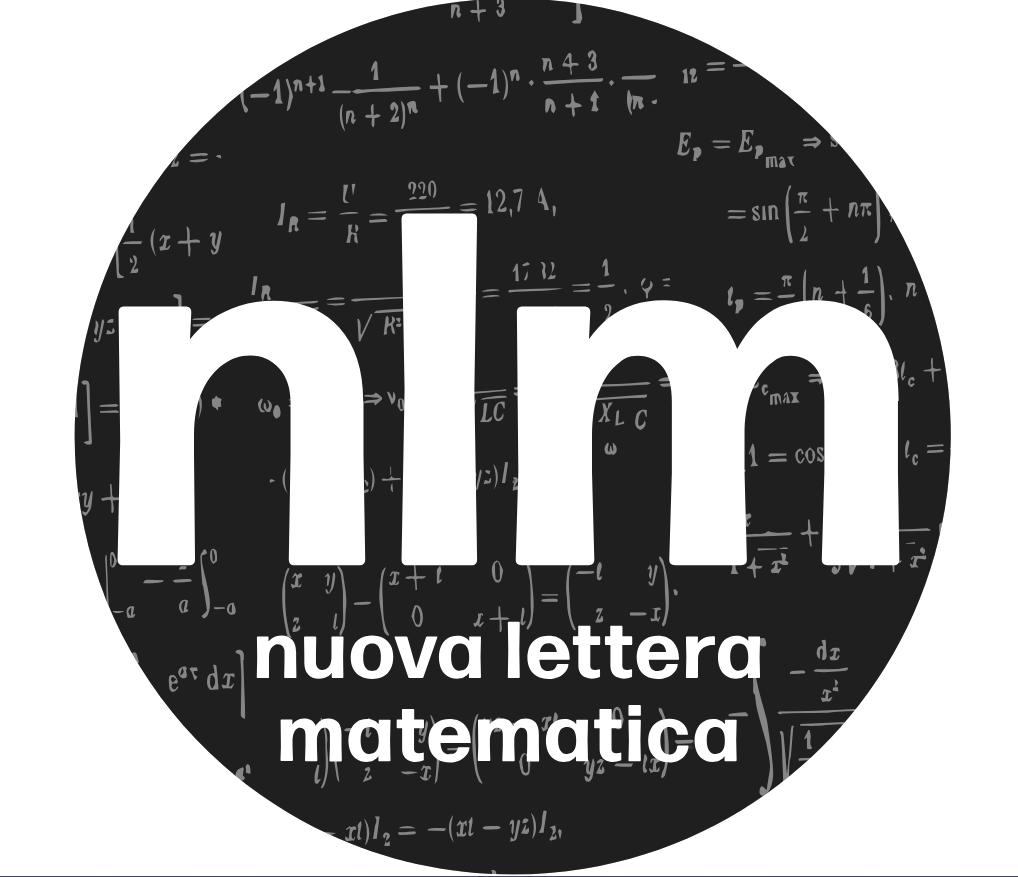Il problema dell’impatto dell’uomo sull’ambiente non può essere affrontato facendo ricorso soltanto alla scienza e alla tecnologia, ma occorre un nuovo paradigma culturale e una diversa narrazione del rapporto fra umanità e natura. Della quale, peraltro, l’umanità è parte integrante.
Lo scrittore Italo Calvino (1923-1985) è stato uno dei primi scrittori ad aver riflettuto su questo problema in alcuni suoi racconti e romanzi, come, ad esempio, nei racconti lunghi “La nuvola di smog”, pubblicato nel 1958, e “La speculazione edilizia”, pubblicato nel 1963.
Calvino è riuscito a comunicare in modo elegante e incisivo questi concetti anche ne “Le città invisibili”, pubblicato nel 1972, formato da brevi narrazioni di città immaginate, sognate o ottenute idealizzando città note; nelle quali non si parla solo della loro struttura architettonica e urbanistica, ma anche dei rapporti fra città e territorio, città e abitanti, memorie che formano il tessuto storico, il vissuto di una città, dei desideri, e degli scambi di merci, di esperienze e sentimenti. Ma, oltre a queste descrizioni in forma di short stories, Calvino ha sentito il bisogno di creare una metastoria, cioè una narrazione che fa da cornice, all’interno nella quale le storie sono inserite, un po’ come avviene nelle “Mille e una notte”. Ha quindi introdotto un narratore, il celebre viaggiatore del XIII secolo, Marco Polo, il quale descrive, e soggettivamente presenta, le città che ha visto nel corso del proprio cammino all’imperatore dei Tartari Kublai Kan, col quale instaura un interessante dialogo che si svolge fra un capitolo e l’altro. In sostanza Calvino immagina che l’imperatore desideri conoscere il suo enorme impero (cosa ormai impossibile proprio per la sua vastità), e allora manda Marco Polo come ambasciatore affinché gli racconti ciò che vede nelle città che incontra. A un certo punto però Kublai Kan si rende conto con una elencazione delle città una per una, mai arriverà a conoscere l’impero nella sua totalità. Comincia quindi a cercare di individuare proprietà, strutture, categorie che caratterizzino il suo impero e che vadano oltre le semplici descrizioni. Cerca, quindi, schemi e algoritmi che permettano di capire la struttura e i princìpi su cui si basa il suo impero. È quello che si dice quando, in matematica, si vuole definire un insieme: per elencazione dei suoi elementi o mediante delle proprietà caratteristiche.
L’imperatore riflette anche sullo stato di conservazione del suo impero, su cittadini capaci di vivere senza perturbare l’ambiente, come gli abitanti di Bauci che guardano il mondo da lontano “contemplando affascinati la propria assenza”. Oppure sulla fragilità delle città, come la città di Ottavia sospesa su una rete sotto la quale c’è l’abisso, ma “la vita degli abitanti d’Ottavia è meno incerta che in altre città. Sanno che più di tanto la rete non regge”.
Un’affermazione molto attuale, specie se messa in relazione con i problemi di sostenibilità di vita nelle metropoli e considerando la fragilità mostrata da aggregazioni urbane. Fino alla straordinaria definizione di sviluppo sostenibile, espressa dalla frase “crescere in leggerezza”, riferita alla città di Lalage. Possiamo persino definire questa opera di Calvino una “poetica della sostenibilità”.
Molto interessante è anche il dialogo: Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra. «Ma qual è la pietra che sostiene il ponte?» chiede Kublai Kan. «Il ponte non è sostenuto da questa o quella pietra − risponde Marco, − ma dalla linea dell’arco che esse formano». Kan rimane silenzioso, riflettendo. Poi soggiunge: «Perché mi parli delle pietre? È solo dell’arco che m’importa». Polo risponde «Senza pietre non c’è arco».
Qui Calvino descrive, in modo estremamente chiaro, il problema della composizione, cioè della relazione fra il tutto e le parti che lo compongono, in quanto spesso il tutto ha proprietà globali (dette anche proprietà emergenti) non deducibili dallo studio delle singole parti. È uno dei temi che stanno alla base dello studio dei sistemi complessi, come quelli che si incontrano comunemente nell’ambito delle scienze ambientali (si pensi al cambiamento climatico). Problemi che devono essere affrontati attraverso azioni globali, concertate, con un approccio sistemico, ma ogni azione globale è composta di tante azioni locali che la sostengono:
L’articolo si conclude con una originale intervista al fisico Frank Raes, che ha realizzato a Laveno Mombello, sul lago Maggiore, il Museo dell’Antropocene, proprio ispirandosi ad alcune opere di Italo Calvino. Nell’intervista Frank racconta che il museo è stato fondato nel 52017, ovvero 6 anni fa, e si occupa di un’epoca intorno agli anni 2000, cioè 50000 anni fa, un’era che già in quei tempi veniva chiamata Antropocene. La maggior parte dei reperti dell’Antropocene vengono da uno strato geologico molto vicino alla superfice della Terra, in cui troviamo una varietà enorme di cose: radioattività artificiale, copertoni, calcestruzzo, chips di silicio, caffettiere con scritto “Bialetti”, guanti di plastica, mattoncini con scritto “LEGO”, flaconi, pillole di ogni forma e misura, …
Ci sono anche libri, importanti perché sono datati e alcuni contengono molte informazioni della loro epoca. Per esempio, abbiamo trovato dei rapporti che parlano in grande dettaglio di un cambiamento del clima terrestre, a causa delle attività dell’umanità. Da altri testi capiamo che, poco prima della fine dell’Antropocene, quasi tutte le informazioni venivano raccolte in “silicium based information systems” (detti anche chip), invece dei “carbon based information systems“ (ovvero i libri). Mentre i dati scritti sui libri sono stati decifrati già 300 anni fa, finora nessuno, nonostante sforzi enormi a livello globale, è riuscito a estrarre le informazioni contenute nei chip. La fine dell’Antropocene è certamente descritta in questi chip, ma temiamo che non riusciremo mai a conoscerla. Tra i libri uno risulta di particolare importanza, le Lezioni Americane di Italo Calvino, scritto nel 1985 e pubblicato per la prima volta nel 1988. Calvino si rendeva conto già allora che l’umanità si stava sbagliando, che la visione del mondo era troppo antropocentrica e che le attività dell’uomo avevano un impatto devastante sulla natura. Le sue “Lezioni americane” erano proposte per il terzo millennio, ed è un po’ triste dover constatare che la civiltà alla quale rivolgeva quelle proposte, come in un suo testamento spirituale, è probabilmente scomparsa proprio durante quel terzo millennio.
Gian Italo Bischi
Sintesi di Gian Italo Bischi, Italo Calvino, testimonial dell’antropocene, Nuova Lettera Matematica, 1 Nuova Serie, Scienza Express Edizioni, 36-47 (2023).
Scarica l’articolo completo apparso sulla rivista Nuova Lettera Matematica.