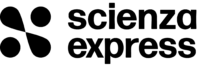L’ultima decade dell’Ottocento viene definita l’età d’oro delle radiazioni. Nel 1895, in Germania, Wilhelm Röntgen scopre che i raggi catodici, colpendo la parete di vetro di un tubo di scarico, producono una radiazione invisibile, capace di produrre fluorescenza e di ionizzare i gas. Röntgen chiama questa radiazione raggi X ed evidenzia che essi non sono deviati né da un campo magnetico né da un campo elettrico, che possono attraversare corpi opachi alla luce e impressionare una lastra fotografica (si scoprirà che si tratta di luce, onde elettromagnetiche di lunghezza d’onda molto piccola). Una di queste prime radiografie mostra la mano della moglie di Röntgen. Tale immagine provoca un’enorme sensazione: le ossa della mano sono chiaramente visibili! Nel 1896, in Francia, Henri Becquerel scopre che i sali di uranio producono un nuovo tipo di radiazione: come i raggi X essa risulta invisibile agli occhi, può attraversare i corpi opachi, può ionizzare l’aria e impressionare lastre fotografiche; ma non ha bisogno di schermi o raggi catodici per essere prodotta; non può essere spenta o accesa; è una proprietà intrinseca dei materiali contenenti uranio. È la scoperta della radioattività. I successivi esperimenti dei coniugi Curie, in Francia, e di Ernest Rutherford, in Inghilterra, permettono di distinguere tre diversi tipi di radiazione emessa: i raggi α (in realtà dei nuclei di atomi di elio), i raggi β (in realtà degli elettroni), i raggi γ (in realtà, luce, onde elettromagnetiche di lunghezza d’onda piccolissima). Ed ecco che, nel marzo 1903, i fisici vengono sorpresi dalla notizia della scoperta da parte di René Blondlot, famoso professore di fisica dell’università di Nancy in Francia, dell’emissione da parte di numerose sorgenti, la fiamma di un bruciatore, dischi metallici e barrette di ceramica incandescenti, di una nuova specie di radiazione invisibile, i raggi N (N come Nancy). Questa prodigiosa scoperta viene compiuta mediante l’osservazione diretta, a occhio nudo, delle variazioni di intensità di una piccola scintilla piazzata di fronte alla presunta sorgente dei raggi N. Questa scintilla viene prodotta fra due punte di platino poste a pochissima distanza fra di loro, in modo che la scintilla stessa sia molto debole, corta e per quanto possibile continua. Una vera fatica per i poveri occhi dello sperimentatore! Nell’arco di poco tempo, più di centoventi scienziati pubblicano circa trecento fra articoli e libri sull’origine e le caratteristiche spettacolari di questa radiazione. Sembra che questa radiazione sconosciuta sia capace di attraversare la carta nera, il legno fino a un certo spessore, i metalli, ma non la carta bagnata e l’acqua; sembra che essa non produca fluorescenza e non impressioni le lastre fotografiche e che possa essere immagazzinata e riemessa da diversi materiali. La sorgente di raggi N più intensa è, però, il sole e questo rende gli studi molto più semplici. Basta infatti disporre di una stanza con una finestra esposta al sole, chiusa ermeticamente da uno spesso pannello di legno. Il legno impedisce il passaggio della luce, ma non della nuova radiazione invisibile, che può così essere liberamente indagata al buio. Come nel caso dei raggi X, la speranza è che i raggi N possano essere utili in medicina. I raggi N, infatti, accrescono la sensibilità della vista, del tatto, dell’udito e del gusto. Anche i vegetali possono emettere raggi N, effetto che viene indebolito se le piante sono esposte ai vapori del cloroformio. È forse nato un metodo per capire quando l’anestesia ha effetto, e infatti altri ricercatori provano che il corpo umano, sottoposto ad azione anestetizzante, affievolisce le sue capacità di emissione dei raggi N. Studiando l’emissione di raggi N nei casi patologici, si scopre che i muscoli paralizzati ne emettono molto meno dei muscoli attivi. Lo stesso vale per i tessuti muscolari morti. Ha inizio un’accesa discussione sulla possibilità di utilizzare la terminata emanazione dei raggi N come prova definitiva dell’avvenuto decesso di un paziente. I raggi N possono essere di aiuto sia in sala operatoria sia nei casi di morte apparente.
Il meraviglioso giocattolo, però, sta per rompersi, molti altri ricercatori non riescono a vedere gli effetti dei raggi N. Troppo aleatorio il metodo basato sulla vista del ricercatore. E, come nella favola del vestito nuovo dell’imperatore, occorre che arrivi un bambino a gridare che il re è nudo. Nel nostro caso il bambino è Robert Wood, un americano, esperto di ottica, professore alla Johns Hopkins University di Baltimora, che per lunghi anni ha lavorato in Europa. Wood è lo scopritore del fenomeno della risonanza ottica e inoltre, per hobby, è un abile prestidigitatore. Conosce bene sia il francese sia il tedesco e si è già occupato di raggi N senza successo. Nell’autunno del 1904 arriva a Nancy deciso a indagare a fondo la questione. Blondlot lo accoglie con piacere e lo fa assistere agli esperimenti nel suo laboratorio, condotti assieme al suo assistente Wirtz. E qui Wood si produce in una strana performance. Pur conoscendo la lingua francese Wood discute con Blondlot in tedesco, dato che quest’ultimo non comprende l’inglese. Spera così di cogliere qualche forma di intesa fra Blondlot e l’assistente. Gli esperimenti avvengono al buio e Wood approfitta dell’oscurità e delle sue abilità di prestidigitatore. Assiste a un esperimento, che sembra aver successo, di misurazione della variazione di luminosità sullo schermo dovuta ai raggi N, in cui Blondlot acuisce la sua vista tenendo vicino alla testa un disco metallico, noto emettitore di raggi N. Wood gentilmente si offre di impugnare il disco per facilitare Blondlot nelle sue operazioni. Non visto, sostituisce il metallo con un piano di legno non lavorato, una delle poche sostanze che, secondo i ricercatori, non emanano raggi N. L’esperimento viene ripetuto ma il risultato non cambia. Blondlot continua a vedere bene le variazioni di brillantezza della scintilla. Wood tace. Blondlot passa poi alla misurazione dell’indice di rifrazione dei raggi utilizzando un prisma di alluminio. Wood, silenzioso e rapido, rimuove il prisma, senza che Blondlot e Wirtz se ne rendano conto. L’esperimento prosegue normalmente e Blondlot ottiene gli stessi risultati di sempre. Prima che la luce venga accesa, Wood ripone il prisma al suo posto, tacendo ancora una volta. L’assistente però ha notato qualcosa e d’accordo con Blondlot propone di ripetere l’esperimento. Allo spegnersi della luce Wood rumorosamente si avvicina al prisma senza toccarlo, l’assistente in francese avverte Blondlot che l’americano ha combinato qualcosa, Blondlot si dichiara stanco e gli esperimenti hanno fine. Wood ringrazia e la sera stessa scrive un rapporto per Nature, dove riporta tutta questa sua avventura con dovizia di particolari. È la fine della favola dei raggi N. I raggi N non esistono, si trattava solo di un fenomeno soggettivo, la loro osservazione era dovuta all’anatomia della retina oculare e a un processo di autosuggestione facile a innescarsi quando l’osservatore contemporaneamente conduceva anche l’esperimento.
Stefano Ossicini
Per saperne di più
- Silvano Fuso, La falsa scienza, Carocci, 2013.
- Mary Jo Nye, N-rays: An episode in the history and psychology of science, Hist. Stud. Phys. Biol. Sci. 11, 127 (1980).
- S. Ossicini, L’universo è fatto di storie, non solo di atomi, Neri Pozza, 2012.