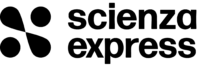Il 7 ottobre Chasles volle replicare alle critiche dicendo di aver già risposto a Duhamel e Le Verrier nei suoi precedenti interventi, ma che, evidentemente, oramai convinti della falsità delle lettere di Pascal, non volevano ascoltare le sue parole e prendere atto che egli aveva già messo tutto il suo materiale a disposizione dei critici. Voleva invece rispondere all’unica critica nuova emersa nella seduta precedente, e cioè quella contenuta nella lettera di Grant a proposito dei numeri. Numeri che si trovavano in una nota di Pascal inviata a Newton e da lui trascritte e in una lettera di Newton indirizzata al fisico Jacques Rohault. Newton non se ne servì nella prima edizione dei Principia del 1687 perché non sapeva come Pascal li avesse calcolati e perché i suoi calcoli davano risultati diversi. Newton si sarebbe servito nel 1729 delle osservazioni di Pound e Cassini. Ma che ne sapeva Grant? Conosceva queste osservazioni? Poteva provare ciò che aveva scritto? Fortunatamente egli era in grado di produrre nuovi documenti a sostegno della sua tesi e l’ammirazione per Pascal si sarebbe ancora accresciuta, perché quei calcoli egli li aveva fatti a diciott’anni, nel 1641, basandosi su degli scritti inediti di Keplero e sulle osservazioni astronomiche che gli aveva trasmesso Galileo in persona. Chasles infatti portava all’attenzione dell’Accademia nuovi documenti: di Galileo, che aveva intuito come l’ellisse di Keplero potesse essere una conseguenza dell’attrazione in ragione inversa del quadrato della distanza e lo comunicò a Pascal; di Pascal che sviluppò questa idea e la confermò, meritandosi fama immortale; di Huygens, Mariotte, Newton, del Cardinale di Polignac, di Malebranche, tutti concordi nell’affermare che era stato Pascal a calcolare i valori che sarebbero poi comparsi nell’edizione dei Principia di Newton del 1729. Ecco alcune delle lettere di Galileo prodotte dal cocciuto Chasles:
Il 2 gennaio 1641 Galileo scrive da Firenze a Pascal sulle leggi di Keplero, suggerendo che si potrebbero giustificare con la teoria della gravità. “Infatti, secondo me, la forza centripeta esercita su uno stesso corpo un’azione variabile a seconda delle diverse distanze dal centro, in ragione inversa del quadrato delle distanze. Vi ho fatto partecipe di un buon numero di mie osservazioni su questo argomento. Vi invio anche diversi scritti di Keplero che posseggo, che riguardano lo stesso soggetto. Vi pregherei di restituirli quando ne avrete preso conoscenza. Non vi scrivo di più, perché mi sento gli occhi molto stanchi. La mia vista se ne va”.
Il 20 maggio successivo Galileo sostiene di essere venuto a conoscenza degli esperimenti di Pascal sulla pesantezza dell’aria e li giudica utili alle osservazioni astronomiche. “Ma, sfortunatamente per me, non mi sarà sicuramente più possibile seguirne a lungo i progressi. La mia vista se ne sta andando sempre di più, ed è con tutte le pene del mondo che vi scrivo”…
Il 7 giugno Galileo scrive ancora a Pascal, dicendo che la pesantezza dell’aria (la forza di gravità) è la stessa che agisce su tutti i pianeti. Per esempio, la Luna pesa sulla Terra, i satelliti di Giove pesano sul quel pianeta, i satelliti di Saturno su Saturno e infine tutti i pianeti insieme pesano sul Sole. Valutando lo scarto prodotto sull’orbita dei pianeti dalla massa dei loro satelliti, allora si può determinare “come voi avete già fatto nel vostro trattato”, la proporzione della gravità di un pianeta verso il Sole e di un satellite verso il suo pianeta e loro loro rispettive distanze. “Ho esaminato con molta cura i calcoli delle forze che possono agire su questi corpi a distanze uguali dal Sole, da Giove, da Saturno e dalla Terra, e queste forze danno perfettamente la proporzione di materia contenuta in questi diversi corpi, conformemente alla legge generale della variazione della gravità, come avevo intuito. È dunque per questi principi che si trova che le quantità di materia del Sole, di Giove, di Saturno e della Terra stanno tra di loro come i numeri 1, 1/1067, 1/3021, 1/169282 così come avete benissimo dimostrato nel vostro trattato”...
Chasles commentò rimarcando che:
- Galileo aveva già intuito teoricamente la legge d’attrazione in ragione dell’inverso del quadrato delle distanze;
- egli possedeva delle osservazioni astronomiche che inviò a Pascal;
- Galileo gli inviò inoltre delle osservazioni di Keplero, il quale aveva lasciato numerosi scritti;
- Galileo non solo aveva scoperto i quattro satelliti di Giove, ma anche quelli di Saturno, precedendo la scoperta di Huygens del 1655 [in realtà Huygens aveva scoperto solo Titano: gli altri erano stati osservati da Gian Domenico Cassini e da William Herschel];
- Galileo parlava di un Trattato scritto da Pascal nel quale egli aveva messo su carta i suoi meravigliosi calcoli;
- 04le lettere degli altri grandi personaggi facevano riferimento a questo Trattato e ne testimoniavano l’esistenza.
Marco Fulvio Barozzi