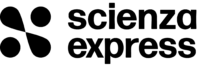Intorno al 1730 giunge a Messina, su di una nave spagnola, un bambino africano, di circa otto anni, venduto e comprato come schiavo sulle coste dell’Africa occidentale. Il ragazzino viene donato a una nobildonna del luogo, una marchesa, che ne apprezza subito le doti e decide di farlo studiare. In poco tempo il ragazzo impara l’italiano e il francese e sceglie di farsi battezzare. Opta come nome per Angelo, e al nome viene aggiunto come cognome Soliman, un richiamo forse all’esoticità della sua origine. Pochi anni dopo arriva in Sicilia, allora governata dagli Ausburgo, un nuovo governatore, il principe Georg Christian von Lobkowitz, che s’innamora dell’idea di avere al suo servizio quel giovane nero tanto sveglio. Allora, fra la fine del Seicento e la metà del Settecento, il possedere dei servi di colore era diventata una vera e propria mania fra i nobili europei. La marchesa siciliana, malvolentieri, regala Angelo al governatore.
Per due decenni, Angelo Soliman seguirà il principe in tutte le sue diverse missioni e destinazioni, vivendo per lo più a Vienna e salendo dal ruolo di schiavo a quello di uomo libero, di soldato e ufficiale. Combatterà in battaglia accanto al principe distinguendosi per la sua abilità e salvandolo anche dalla morte. Nel 1755, dopo il decesso del Lobkowitz, Angelo Soliman, da uomo libero, passa al servizio, sempre a Vienna, del principe e feldmaresciallo Wenzel von Liechtenstein, occupandosi fra l’altro dell’educazione del nipote di quest’ultimo, Franz Joseph. Angelo padroneggia ormai l’italiano, il francese, l’inglese, il tedesco, il boemo. Il principe Giuseppe II, figlio dell’imperatrice Maria Teresa, onorerà Angelo Soliman della sua amicizia e lo vorrà nel corteo trionfale, al suo ingresso a Francoforte, nel 1765, in occasione della sua incoronazione a imperatore del Sacro romano impero.
Il 6 febbraio del 1768 Angelo sposa la nobildonna e vedova Magdalena von Christiani, nata von Kellermann. Angelo si trasferisce con la moglie in una casa che aveva acquistato sempre a Vienna e lavora da indipendente, per mantenersi. Nel 1772 nasce sua figlia Josepha, detta Josephine, che alla fine del secolo sposerà il barone Ernst Freiherr von Feuchtersleben. Josephine figlia di un’europea e di un africano, una, che di lì a poco sarà descritta nei testi dedicati allo studio delle “razze” come una mezzosangue, una bastarda, una mulatta. Sempre nel 1772, Franz Joseph von Liechtenstein prega Angelo Soliman, che era stato il suo istitutore, di tornare a vivere, con la propria famiglia, nella residenza del principe. Ora per assolvere al compito di precettore di suo figlio Alois Joseph. Angelo accetta. Nel 1781 Soliman entra, poi, a far parte della Loggia massonica “Zur wahre Eintracht” (La vera armonia) di cui sono membri, fra gli altri, i musicisti Wolfgang Amadeus Mozart e Josef Haydin, il medico e scopritore del magnetismo animale Franz Anton Mesmer, lo scienziato Ignaz von Born, lo scrittore e naturalista Georg Forster, e il poeta nazionale ungherese Ferenc Kaczinczy e ne scala rapidamente i diversi gradini di potere, fino a diventare vice maestro delle cerimonie. La loggia “Zur wahre Eintracht” era il vero e proprio centro pulsante dell’illuminismo viennese.
Il 21 novembre 1796, Angelo Soliman muore improvvisamente d’infarto. E qui, dopo la sua morte, avviene qualcosa di straordinario. Il corpo di Angelo Soliman viene immediatamente sequestrato dalle autorità imperiali. Un’autopsia viene eseguita, la testa viene staccata dal tronco e il restauratore Franz Thaler ne fa una maschera mortuaria, da cui ricava un busto in gesso. Il medico Carl Eberlé distacca poi dal corpo completamente la pelle, pelle che viene preparata e consegnata a suo fratello l’abate Simon Eberlé, curatore del Gabinetto delle curiosità (una Wunderkammer, un gabinetto delle meraviglie, un precursore dei moderni musei) del nuovo imperatore Francesco II, nipote di Giuseppe. Malgrado le sue proteste, la figlia Josephina non otterrà mai indietro i resti di suo padre. È che con la pelle mummificata di Soliman viene rivestito un pupazzo di legno che, utilizzando la maschera mortuaria, riprende le sue fatture; un manichino a grandezza naturale che viene esposto al pubblico nella Wunderkammer.
Com’è stato possibile che una persona, rispettata e apprezzata da tutti, membro della chiesa locale, sposata con una nobildonna, il genitore di una ragazza che aveva avuto come padrini al suo battesimo diversi nobili di corte, un membro emerito della più prestigiosa Loggia massonica di Vienna, venga, subito dopo la morte, deumanizzata al punto tale che il suo corpo profanato finisce prima brutalmente smembrato, poi viene affidato a un imbalsamatore, infine viene privato della pelle, facendo uso di grossi coltelli anatomici pensati per i grandi animali, e trattato come una comune preda di caccia da dover impagliare. E da ultimo venga poi gettato in pasto alla curiosità malsana del pubblico, nudo, ricoperto di piume e collanine, in una sorta di esibizione “etno-pornografica”.
È proprio negli ultimi decenni del Settecento che si assiste a un vero e proprio cambio di paradigma scientifico, culturale e sociale nel modo in cui si guarda agli uomini. Così alla sua morte Angelo viene ridotto al suo essere “negro”, quello che conta ed è importante è solo il colore della sua pelle. Soliman scompare come persona, come individuo e viene classificato, senza possibilità di autonomia e di scampo, in una nuova categoria, all’interno di un nuovo concetto, quello della “razza”, una “razza” che viene posta all’interno di un ordine gerarchico rispetto ad altre “razze”, ordine gerarchico che nel suo caso lo pone su uno dei gradini più bassi, visto come un selvaggio senza alcuna possibilità di cambiamento, più vicino a una scimmia, che non agli altri uomini. E questo cambio di visione non avviene solo nell’Austria degli Ausburgo, ma in tutto il mondo occidentale.
Potrebbe essere sorprendente che tutto questo abbia trovato il suo inizio nel secolo diciottesimo, all’interno dell’Illuminismo, con la partecipazione dei grandi filosofi dell’epoca dei Lumi (Hume, Voltaire, Jefferson, Kant), e con il fondamentale contributo dei più eminenti e più influenti scienziati di quel periodo (Linneo, Buffon, Blumenbach, Cuvier). Eppure “Il concetto di razza è una delle eredità più problematiche dell’Illuminismo”. Infatti “razza”, come viene intesa nella modernità, è una nozione che emerge e si sviluppa a partire dal Settecento all’interno di un sistema descrittivo e discorsivo, che diventerà presto normativo. Nella costruzione del concetto di “razza”, il ruolo dei filosofi e degli scienziati è stato determinante e ha contribuito, volente o nolente, a far risalire a una “pretesa” oggettività scientifica la necessità di una distinzione, netta e precisa, fra gli esseri umani. Un’operazione partita dal nominare (stabilire di cosa si sta parlando), un’impresa che ha viaggiato attraverso il classificare (trovare un posto agli, e fra gli, esseri umani nel mondo naturale, soprattutto nel confronto prima con gli animali e in particolare con le scimmie e i primati e poi fra i diversi popoli), una campagna che si è basata sul misurare, divenuto una vera e propria ossessione. Tutte queste misure vennero costruite e pensate per valutare le differenze tra le presunte diverse “razze”, differenze racchiuse in numeri che sono state usati per operare una gerarchizzazione (porre le “razze” su di una scala di merito a partire dal gradino inferiore, quello considerato il più vicino alle grandi scimmie, fino a quello superiore, la “razza” migliore, quella più perfezionata, destinata a governare il mondo) e di conseguenza sono stati infine utilizzati per escludere (limitare i diritti dell’altro, aborrire qualunque tipo di meticciato, augurarsi l’estinzione dell’inferiore, del selvaggio).
L’intreccio contraddittorio, nell’illuminismo, tra aspirazioni universalistiche e concezioni gerarchiche, discriminatorie ha finito per far sì che l’accesa discussione del secolo dei Lumi sulla varietà umana abbia finito nel trasformarsi nell’ossessione e nella paura dell’Ottocento per la “differenza razziale”. Così la costruzione del concetto di “razza”, date le sue nefaste conseguenze, si è rivelata uno dei più grandi errori scientifici della modernità.
Stefano Ossicini
Per saperne di più
- G. Barbujani “L’invenzione delle razze”, Bompiani 2010.
- S. Ossicini “L’invenzione del concetto di “razza””, Meltemi 2024.
- M. Pompei, “Razze umane”, Scienzaexpress 2024.