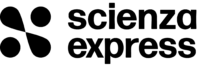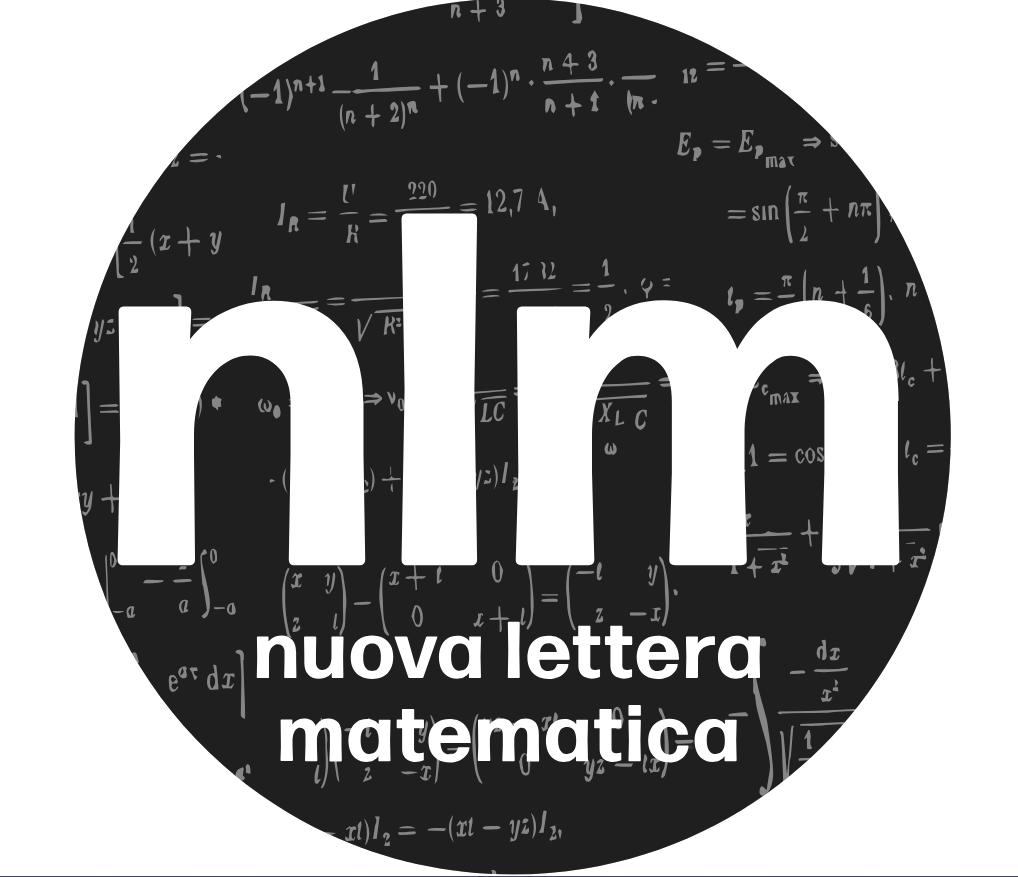Avere un metodo che guidi la ricerca scientifica o, più in generale, la nostra vita sembra essere una buona cosa. Una delle conquiste della rivoluzione scientifica fu proprio l’istituzione di un metodo per la scienza caratterizzato dal rigore, dalle galileiane “sensate esperienze”, dalle “necessarie dimostrazioni” e dalle newtoniane “hypotheses non fingo”. Tuttavia, è anche vero che non sempre il metodo che impieghiamo è appropriato ed efficace per fronteggiare un determinato problema. Allora ha senso chiedersi fino a che punto avere un metodo sia utile.
Il filosofo della scienza Paul Karl Feyerabend, in contrasto con la visione rigida dei suoi contemporanei, sosteneva che la scienza fosse un’impresa anarchica, libera dalle regole metodologiche fisse. Feyerabend promuoveva un approccio pluralista, che accetta metodi diversi, anche se contrastanti, per affrontare i vari problemi scientifici. La scienza, secondo questa visione, non deve aderire a un singolo metodo, ma abbracciare molteplici approcci, come evidenziato nell’opera di Galileo Galilei, che mescolava diverse tradizioni filosofiche e metodologiche. Secondo Paolo Rossi, la nascita della scienza moderna avvenne in concomitanza al graduale abbandono del rigore degli antichi in favore di un nuovo approccio caratterizzato da un “opportunismo senza scrupoli”, in cui il metodo assiomatico-deduttivo della geometria antica veniva gradualmente mescolato con intuizioni provenienti dalla pratica empirica.
Infatti, nelle riflessioni di Galileo convergono diverse tradizioni, nessuna delle quali dominante. Il giovane Galileo venne influenzato dall’aristotelismo, poi dalla tradizione archimedea proveniente dalla scuola urbinate. Più tardi, nel periodo padovano, collaborò con artigiani e ingegneri. Infine, negli scritti di Galileo si possono trovare tracce platoniche. Tutte queste influenze hanno contribuito al pensiero del toscano. Chiamiamo questo atteggiamento l’“opportunismo dei moderni”. Questo però non significa che tutti i metodi vadano bene, come suggerito da Feyerabend. Vale la pena distinguere fra quello che possiamo chiamare il “monismo metodologico”, secondo cui esisterebbe il metodo della scienza, l’“anarchismo metodologico”, secondo cui anything goes, e il “pluralismo metodologico”, che accetta più metodi adeguati, anche in contrasto fra loro, e la scoperta di sempre nuovi metodi; ma non tutti i metodi sono adeguati in tutte le situazioni.
Partendo dal problema dell’insegnamento della matematica proposto con efficacia in Italia da Emma Castelnuovo, ci sembra utile ricordare l’importanza dell’insegnamento di più metodi per favorire il pensiero creativo. Secondo Emma Castelnuovo, l’insegnamento della matematica non dovrebbe limitarsi a trasferire conoscenze, ma deve sviluppare capacità di analisi e problem-solving, stimolando il pensiero creativo. Il pensiero creativo non è solo pensare liberamente, ma adattare il metodo al problema da risolvere. In questo contesto, il pensiero divergente (l’abilità di generare molteplici soluzioni) è essenziale per la creatività.
Prendiamo ancora il caso di Galileo. Il toscano combinava approcci diversi (ad esempio, platonismo, empirismo, pitagorismo) per affrontare i suoi problemi scientifici. Un esempio dell’approccio “opportunista” di Galileo è il suo trattamento del concetto di continuum e della resistenza dei solidi. Nel suo Dialogo, Galileo mescola analisi geometriche con riflessioni fisiche, utilizzando concetti come il vuoto, gli atomi indivisibili e l’infinito per risolvere problemi pratici, come la resistenza dei corpi solidi. Le sue considerazioni sul vuoto e sugli atomi indivisibili, pur non essendo matematicamente rigorose, sono esempi di come Galileo fosse capace di adattare il suo metodo alle circostanze. Lo stesso Albert Einstein parlava di “opportunismo metodologico”, suggerendo il fatto che gli scienziati non seguano sempre un unico schema, ma adattino il loro approccio a seconda del problema.
La storia della scienza ha dimostrato che i progressi significativi sono stati ottenuti proprio grazie alla varietà dei metodi usati e alla capacità di combinare approcci diversi. La versatilità e la flessibilità metodologica non solo favorisce la comprensione della realtà, ma stimola anche la creatività, fondamentale nel progresso scientifico. La capacità di adattarsi, di integrare diverse metodologie e di non temere di cambiare prospettiva è cruciale per il progresso scientifico e per la creatività. La scienza non procede per un unico metodo, ma si arricchisce attraverso l’applicazione di diversi approcci, rendendo possibile una comprensione più profonda della realtà, pur riconoscendo i limiti della conoscenza. L’insegnamento dovrebbe promuovere questa versatilità, affinché gli studenti imparino a usare diversi metodi per affrontare problemi e stimolare il pensiero divergente. In ambito educativo, insegnare a usare più metodi può sviluppare il pensiero divergente, aumentando la capacità di affrontare le sfide quotidiane in modo creativo.
Vincenzo Fano
Davide Pietrini
Sintesi di Vincenzo Fano, Davide Pietrini, L’opportunismo metodologico nella rivoluzione scientifica di Galileo, Nuova Lettera Matematica, 4 Nuova Serie, Scienza Express Edizioni, 44-55 (2024).
Scarica l’articolo completo apparso sulla rivista Nuova Lettera Matematica.