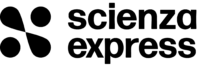La seconda presidenza Trump si è aperta nel segno di molte tensioni, una delle quali – e non la minore – è quella tra la nuova amministrazione e la ricerca scientifica: dai termini che devono scomparire dai progetti di ricerca statunitensi, al ritiro degli Stati Uniti d’America dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dagli accordi di Parigi, al taglio dei finanziamenti federali a Harvard, solo per citare le più eclatanti.
La destra sovranista e che occhieggia alle democrature ha una particolare attenzione nei confronti della ricerca scientifica, della misurazione e della raccolta dei dati, della libertà stessa di ricerca. Lo abbiamo visto esplicitamente con i legami stretti, anche se non esclusivi, col movimento no-vax, lo vediamo con lo scetticismo, di giorno in giorno più esplicito, su virus e crisi climatica.
In Italia, dove abbiamo il gusto di trasformare la tragedia in farsa, assistiamo tra il serio e il faceto alle dichiarazioni del ministro Lollobrigida che ci garantisce la salubrità sempre e comunque del vino basandosi sul fatto che “Gesù lo moltiplicò”. (Sorvoliamo sull’errore da primo anno di catechismo e sulla confusione tra la moltiplicazione dei pani e dei pesci e la trasformazione dell’acqua in vino.)
La ricerca scientifica che, di suo, non vorrebbe essere etichettata con un colore politico, si trova inevitabilmente, e con una certa violenza, trascinata nell’agone politico. La destra insofferente della democrazia, della giustizia e delle letture del mondo indipendenti dalla propria ideologia, sceglie i dati, le evidenze e le prove scientifiche come bersaglio. Nega il valore di una ricerca purché sia e ne prende le distanze, trascurando le città che vanno a fuoco, le coste spazzate dagli tsunami, le reti ferroviarie ed elettriche sovraccariche di troppi consumi e di altrettante negligenze nella manutenzione (al netto dei chiodi, beninteso). E così alle donne e agli uomini di scienza non rimane che prendere in mano un vessillo che è di tutti, ma che una minoranza fa sembrare di parte.
È quello che è successo nelle elezioni presidenziali attualmente in corso in Romania dove uno dei due contendenti, ancora in gara per il ballottaggio del 18 maggio, è il matematico Nicușor Dan, già due volte medaglia d’oro alle Olimpiadi Internazionali della Matematica (nel 1987 e nel 1988, entrambe le volte con 42 punti conquistati su 42), e che poi a Parigi conseguì un master all’École normale supérieure e un dottorato all’Università Paris 13. Non è un caso che la sua formazione matematica di respiro europeo sia uno dei fattori, professionali e di vita, che ne ha fatto un leader politico, nonché sindaco di Bucarest, e oggi la miglior alternativa alla destra nazionalista.
La ricerca scientifica diventa terreno politico anche in Europa dove, sempre in questi giorni, alla Sorbona, il vertice dei ministri per la ricerca dell’Unione Europea lancia una chiamata ai ricercatori che lavorano negli Stati Uniti perché scelgano l’Europa per il loro lavoro futuro. È una tipica situazione win-win nella quale entrambe le parti hanno da guadagnare: i ricercatori perché trovano nuove condizioni di libertà e di sostegno alla loro ricerca, l’Unione Europea perché attira intelligenze ed esperienze essenziali per guardare a un futuro autonomo e sostenibile. All’iniziativa, fortemente voluta dal presidente francese Emmanuel Macron, dà la sua copertura la presidente Ursula von der Leyen. L’Italia, non certo prima per sostegno alla ricerca, si nota per l’assenza della ministra Bernini e per la presenza solitaria dell’ambasciatrice a Parigi.
Insomma, in un momento in cui le questioni politiche rilevanti – non quelle della politichetta politicata – sono tutte nel segno della ricerca scientifica (crisi climatiche, crisi demografica, gestione e sviluppo dell’IA, energia, ogm, vaccini, gestione delle pandemie prossime venture ecc. ecc. ecc.), la destra sovranista e insofferente alle regole elegge la ricerca scientifica stessa come voce scomoda e le scarica addosso la potenza della comunicazione social e di scelte politiche che portano a tagli e limitazioni dell’autonomia difficilmente comprensibili, soffiando sul fuoco di ignoranza e confusione.
E così ci troviamo con un ex-ragazzo nerd e piuttosto dotato, che vinte le Olimpiadi Internazionali della Matematica, decide che ci sono altre competizioni da vincere, prima quelle da sindaco di Bucarest, oggi quelle per la presidenza della Romania. E che ci indica la strada di una partecipazione politica che non può permettersi di considerare tutte le opzioni sul tavolo come equivalenti per la ricerca e per la scienza, per l’umanità e per il pianeta.
Pensiamoci. E speriamo che ci pensino i giovani che proprio in questi giorni competono per le Olimpiadi della Matematica, in Italia, in Europa e nel mondo. Abbiamo bisogno di più pensiero razionale, di più decisioni che tengano conto delle evidenze scientifiche, di più scelte che non ignorino gli equilibri tra natura, fenomeni e i nostri comportamenti. E, dal nostro punto di vista, abbiamo bisogno di più riflessioni e di più libri che intorno a tutto questo facciano cultura.
Daniele Gouthier
Direttore editoriale delle edizioni Scienza Express