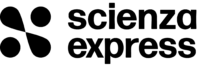La prima seduta del 1868 si tenne il 6 gennaio. In apertura veniva data lettura di una nota di Padre Secchi del 29 dicembre, in cui l’astronomo italiano precisava di non aver voluto dire che i documenti di Chasles erano prodotti man mano che la discussione richiedeva certe testimonianze, ma che essi erano esibiti per sostenere certe tesi. Anch’egli si augurava che Chasles, sul quale non nutriva alcun sospetto di disonestà, procedesse al più presto alla pubblicazione del suo materiale.
Era poi depositata agli atti una lettera del 28 dicembre del filosofo, matematico e storico della scienza Paolo Volpicelli a Chevreul. L’accademico dei Lincei voleva correggere alcune affermazioni di Govi e Secchi in merito alla cecità di Galileo, citando due brani di lettere in cui il grande scienziato diceva di non aver ancora perso la vista dal secondo occhio ancora il 25 luglio 1638. Era inoltre inesatto dire che egli non si occupava più di astronomia, ma solo di meccanica: nel 1640 si occupava ancora di Saturno e nel 1641 difendeva dai dubbi il sistema copernicano. Concludeva poi riportando il brano di un’opera tedesca del 1646 in cui si attribuiva a Pascal il germe delle scoperta di Newton.
________________________________
Paolo Volpicelli (1804-1879), romano, si era laureato in matematica e filosofia nel 1827. Nel 1836 ottenne l’insegnamento di fisico-chimica nel Pontificio seminario romano. Alla morte di Saverio Barlocci, divenne titolare dell’insegnamento alla cattedra di fisica sperimentale alla Sapienza e mantenne l’incarico fino al 1872, quando, in attuazione del piano di riorganizzazione degli studi promosso dal nuovo governo unitario, passò alla cattedra di fisica matematica.
Associata all’insegnamento di fisica era la direzione del gabinetto universitario. Volpicelli riuscì ad ampliare notevolmente la dotazione di strumenti per le esperienze scientifiche e le dimostrazioni pubbliche. Nel 1857, per interessamento di papa Pio IX, la sede del museo fu rinnovata, furono restaurati gli apparecchi, fatti nuovi acquisti e allestiti un laboratorio, un osservatorio meteorologico e un anfiteatro per le dimostrazioni pubbliche, che Volpicelli tenne regolarmente il giovedì di ogni settimana. L’ampliamento del museo continuò negli anni successivi: nel 1858 Volpicelli si recò personalmente a Parigi, dove acquistò tutte le macchine di cui aveva bisogno. Il museo era diventato, ormai, un punto d’attrazione per gli scienziati e per le personalità eminenti in visita nella città.
Quando papa Pio IX fondò nuovamente l’Accademia pontificia dei Lincei nel 1847, Volpicelli, che era stato uno dei fautori della rinascita dell’istituzione, fu nominato segretario. La carica, di durata decennale, fu riconfermata tre volte. Nel 1877, per l’impegno costante profuso, fu acclamato segretario emerito. Ricostruì anche alcuni particolari della biografia di antichi lincei, in particolare di Galileo Galilei e di Federico Cesi. Negli Atti dell’Accademia pubblicò circa la metà dei suoi contributi scientifici.
Volpicelli si dedicò con uguale interesse alla matematica e alla fisica e quest’ultima trattò sia negli aspetti matematici sia in quelli sperimentali. Per motivi di rivalità scientifica, entrò più volte in contrasto con Secchi. Si applicò agli studi di geologia, di meteorologia, di ottica, di termodinamica, di elettricità e magnetismo.
________________________________
Chasles rispose poi per prendere atto della precisazione di padre Secchi, ma imputava il malinteso tra loro due a una certa precipitazione dell’astronomo italiano nelle sue argomentazioni. Quanto a Volpicelli, finalmente il suo era un contributo non prevenuto all’intero dibattito. Le citazioni che riportava, tratte dalle Opere Complete di Galileo rafforzavano le affermazioni fatte dallo stesso Chasles in precedenza. Vi era poi un passaggio di una lettera di Cartesio a Mersenne del 23 febbraio 1643, pubblicata in tutte le edizioni delle Lettere, in cui egli voleva conoscere il giudizio di Pascal sul telescopio inviatogli da Galileo prima di morire. Chasles concludeva dicendo che la biografia tedesca citata da Volpicelli gli era ignota quando, sei mesi prima, aveva presentato la sua prima comunicazione.
Dopo una settimana senza comunicazioni sulla querelle in corso, il 20 gennaio giungeva all’Accademia una nuova lettera di Padre Secchi:
“Nella seduta del 6 gennaio, il Signor Volpicelli ha fatto una comunicazione nella quale cerca di dimostrare che Galileo non era cieco all’inizio del 1638, come avevo detto in una comunicazione precedente. Per questa affermazione, si basa su un passaggio preso da una lettera in latino di Galileo a Boulliau, nella quale si trova l’espressione che significa “scrivo, perché più le cose sono fastidiose da scrivere, più la salute degli occhi non soffre”. Ora, nella medesima lettera, si trova un’altra frase: “Ogni luce dei miei occhi si è estinta (…) e non vedo di più con gli occhi aperti che con gli occhi chiusi”. Se Galileo si trovava in quella condizione, era piuttosto improbabile che, come invece afferma Volpicelli, egli potesse scrivere di sua mano. (…) In un altro passaggio, Galileo dice di non riuscire più a vedere le figure, fatto confermato in una lettera immediatamente successiva al Diodati del 2 gennaio 1638 e in altre missive inviate nei mesi successivi”. Riguardo a Saturno, lo scienziato toscano lo citava già nel 1637 solo per sostenere di non riuscire più a vederlo, mentre l’affermazione che vi fosse qualche forza che governa l’insieme dei pianeti era ben lungi da essere un’anticipazione della gravitazione universale”.
Chasles contestò subito le argomentazioni di Secchi (e Govi, Harting, Martin), dicendo che proprio le sue parole provavano che Galileo non era affatto completamente cieco. In una lettera a Boileau, trovata da Volpicelli, si troverebbe un passaggio perfettamente conclusivo: “Sarò breve perché lo stato dei miei occhi non mi permette di scrivere a lungo”. Padre Secchi aveva citato un altro passaggio della stessa lettera in cui Galileo dice “che non vede più con gli occhi aperti che con gli occhi chiusi”. Ma questo modo di esprimersi, che è quello dei miopi riguardo agli oggetti posti a una certa distanza, non significa che egli fosse cieco completamente, e che non potesse vedere o scrivere con l’aiuto di occhiali.
Chasles, insomma, si attaccava alle quisquilie per difendere la sua tesi, al punto da restituire la vista ai ciechi.
Alla fine della seduta venne data comunicazione di una lunga lettera dell’astronomo Philippe Gustave Doulcet, Conte di Pontécoulant che aveva cercato di ricavare la legge dell’inverso dei quadrati attraverso simulazioni numeriche sulla base dei dati astronomici disponibili ai tempi di Pascal. Ebbene, i numeri forniti nella sua lettera a Boyle non erano assolutamente quelli che ci poteva aspettare, ma erano esattamente quelli pubblicati da Newton. Se ne poteva tranquillamente concludere che tale presunta missiva era stata scritta dopo la pubblicazione dei Principia, ed era un falso palese.
Nella seduta del 27 gennaio, Chasles prendeva la parola per smentire le affermazioni di Pontécoulant, dicendo di aver risposto in merito il 15 e il 22 luglio dell’anno precedente ad analoghe obiezioni di Grant. Dopo questa seduta e mesi tumultuosi, la vicenda delle lettere portate da Chasles sembrava scomparire dai verbali dell’Accademia: egli stesso tornò a fare il matematico e, in alcuni degli incontri settimanali successivi, si limitava a presentare memorie matematiche scritte da altri.
Marco Fulvio Barozzi