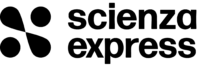Sebbene il titolo possa apparire spiazzante, abituati come siamo a una narrazione “leaderistica”, la quale attribuisce alle decisioni di un singolo uomo al comando il potere di deviare il corso della Storia, vale la pena precisare sin da subito: l’intuizione di fondo è fondata. E mi scuso per il gioco di parole.
In fondo, basterebbe leggere Guerra e Pace per accorgersene (consiglio in particolare l’Epilogo II, capitolo VII).
Purtroppo, pensare e supporre sia vero il contrario succede proprio alle latitudini dove la Storia si è smesso di studiarla. Non solo. Siamo proprio convinti che sia finita (Francis Fukuyama, autore di “The End of History”, si è fatto anche qualche viaggetto per il mondo grazie a questo).
È davvero sconvolgente pensarlo, ma senza Putin è verosimile che la Russia invadesse lo stesso l’Ucraina il 24 febbraio 2022: infatti, è la Russia ad aver generato Putin, non viceversa; è la Russia (e i russi) che esistono da mille anni, non Vladimir Putin. Non sono i singoli a informare i tempi (attuali, passati, futuri), ma le collettività. Le quali, per l’appunto, producono i singoli. Non viceversa.
Torniamo al centro dell’Impero cui perteniamo: gli Stati Uniti d’America. L’America profonda, ridefinita “Trumpiana” secondo (falsa) dizione, non è “Trumpiana” in senso stretto, perché esiste, esisteva e esisterà anche senza l’attuale Presidente degli Stati Uniti. Il rapporto causa-effetto è opposto. È un esercizio difficile, traumatico, e obbliga ad analizzare realmente la situazione al di dentro, senza bollarla frettolosamente con le “classiche” categorie politologiche repubblicani vs democratici (ovvero destra vs sinistra), che effettivamente ci avrebbero risparmiato tempo ed energie mentali. Ma sarebbe stato profondamente parziale, lacunoso e sostanzialmente sbagliato.
Gli Stati Uniti stanno vivendo una profonda crisi identitaria. Non perché siano realmente in crisi, anzi, forse, sono inarrivabili ora più che mai. Si sentono in crisi innanzitutto perché non sono più una potenza “adolescenziale”, che teme il caos e quindi deve intervenire in ogni posto si senta messa in discussione (vedi Corea, Vietnam, Iraq I, Balcani, Afghanistan, Iraq II, Libia, Siria, per non parlare dei conflitti “minori” a bassa intensità, o da remoto). Sono una potenza matura e come tale si sentono insediati da tutte le altre potenze o imperi (Cina, Russia, Iran, Turchia, in primis), anche oltre reale misura.
Si sentono in crisi e profondamente depressi perché stanno vivendo una profonda spaccatura interna che, attenzione, non è democratici vs repubblicani. Come detto quella è solo l’apparenza, la glassa che ricopre la struttura. Sebbene la depressione che li colpisce sia la stessa, ovvero una profonda stanchezza imperiale, il modo di rispondere delle coste è diametralmente opposto a quello dell’entroterra (in nuce, Dixieland e Midwest, quest’ultimo vero cuore pulsante degli USA, di origine germanica). Le coste stanno diventando minimaliste, post-storiche, rinnegano loro stesse e l’impero: in sostanza stanno diventando l’Europa Occidentale. Hanno cancellato la Storia, perché non riescono più a sostenerne il senso di colpa. Anche da qui, la gemmazione della cultura woke. La reazione dell’entroterra (alla medesima depressione) è invece rabbiosa: manutenere da soli un sistema globale da 8 miliardi di persone è stancante e asfissiante, esponenzialmente più difficile rispetto all’alba del 1945, dove vi erano mal contati 1,5 miliardi di persone, di cui metà “Occidentali”, in un mondo spaccato in due. Pertanto, a loro avviso, la gestione deve essere (sub-)appaltata per zone di afferenza, in particolare agli Europei (noi), le province dell’impero, che finora hanno beneficiato “a gratis” dell’ombrello americano.
Da noi, ciecamente, si vede solo lo scontro elettorale, in un paese liberal-democratico dove si vota di martedì, dove bisogna registrarsi settimane prima, dove si può votare per posta, dove non è richiesto un documento di riconoscimento per votare, dove in alcuni Stati centrali bisogna fare decine di miglia per andare a votare, e magari si vota in chiesa, in un parcheggio, in un centro commerciale, in una stazione, o anche in case private. La tragicomica realtà è che la politica negli Usa è presa terribilmente sul serio solo fuori dagli Stati Uniti.
E poi c’è la questione dei “super-poteri” del Presidente. Probabilmente, tra i capi di stato democraticamente eletti nel mondo, è quello con meno poteri in assoluto (a differenza, per esempio, del Presidente francese che è invece a tutti gli effetti un monarca repubblicano, per volere di Charles De Gaulle e Michel Debré). Infatti, la costituzione americana è nata come risposta a una monarchia assoluta (inglese), e c’era tutta la volontà di non trovarsi con un dittatore a Washington anziché a Londra.
Newyorkesi e californiani non stanno credendo più al mito della “città sulla collina” (versetto della Bibbia di Re Giacomo, “Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid”), non si credono più eccezionali e faro dell’umanità. Si assumono colpe e responsabilità presenti e passate. Così come la Disney, sono passati dal Re Leone a Inside-Out. Esempio plastico.
L’America tedesca (il più grande ceppo di migrazione degli Stati Uniti è quello germanico, soprattutto nel Midwest, cioè gli Stati che decidono le elezioni), invece, continua a crederci. E se questo non attecchisce (più) sul mondo, è solo colpa del mondo. È colpa dei clientes europei (e canadesi). Ed è colpa degli americani costieri, che si fanno influenzare.
Per la prima volta nella storia, esiste una questione migratoria in un paese fatto e costruito da immigrati. Perché? Perché, per la prima volta appunto, gli immigrati non arrivano da oltre oceano, ma in larga parte dall’altra parte del fiume: il Rio Grande (o Rio Bravo, per i messicani). Gli Stati Uniti combatterono una guerra contro il Messico e conquistarono quasi metà del suo territorio, arrivando fino a Città del Messico. Texas, Nevada, California, New Mexico, Utah, Colorado, Arizona, Wyoming, hanno fatto parte interamente o in larga parte del Messico fino a metà Ottocento, e oggi gli immigrati messicani sono stanziati in maggioranza proprio in quei territori. Viene difficile assimilare gli immigrati, se nel fine settimana possono tornare “a casa” a trovare i nonni. L’assimilazione è un processo drammatico, traumatico e doloroso. È spogliazione di ogni retaggio originale e antico, ed è tipica degli imperi (per questo, alle nostre latitudini si parla di integrazione, cosa ben diversa). Il muro non è un impedimento fisico, ma una barriera simbolica, psicologica e cultura: serve a questo.
Alcune considerazioni finali: Trump è già stato Presidente. Il tycoon nella campagna elettorale di nove anni fa promise che avrebbe riportato indietro o almeno diminuito i soldati americani nel mondo, che avrebbe aperto alla Russia, che avrebbe diminuito il deficit commerciale, che l’immigrazione sarebbe diminuita. Risultato: i soldati americani sono aumentati, proprio nei paesi baltici (in funzione antirussa), il deficit aumentò, l’immigrazione pure.
Biden promise di abbattere o stoppare la costruzione del muro con il Messico, di migliorare le relazioni con la Cina, di togliere i dazi, di migliorare l’immagine degli Stati Uniti nel mondo. Risultato: i fondi per la costruzione del muro sono aumentati, le relazioni con la Cina sono pessime e sono stati introdotti forti dazi, e Occidente a parte, gli Stati Uniti sono odiati da 7/8 (sette ottavi) del mondo. È sufficiente osservare qualsiasi votazione di rilievo all’ONU (che non conta nulla, ma perlomeno chiarisce le idee), come per esempio l’ingiustificabile aggressione militare russa contro l’Ucraina che non è stata condannata (sommando le popolazioni dei rispettivi Stati) dalla maggioranza del pianeta.
Non è che Trump o Biden fossero in cattiva fede: la volontà di una sola persona non cambia la cifra antropologica di una nazione (meno che mai di un impero), né il suo percorso. Non è Trump ad aver generato questo momento storico, questo sentimento, questo senso di depressione e stanchezza americana, ma proprio l’opposto. Lui lo cavalca, e bene.
Se imparassimo a distrarci meno dagli scontri-dibattiti mediatici, quasi esistessero per davvero, e concentrarci invece su cosa vorranno fare “da grandi” gli Stati Uniti, magari potremmo comprendere meglio la profondità delle cose, altrimenti battiamo i piedi e non capiamo come mai Trump vinca. E non c’entra nulla l’economia. L’economia è sempre strumento e mai fine per le grandi potenze.
Ma questo è tutto un altro discorso.
Alessio Ricci
Per saperne di più:
- Braudel, F., & Wallerstein, I. (2009). History and the social sciences: the longue durée. Review (Fernand Braudel Center), 171-203.
- Peters, M. A. (2023). Who Leads, Who Follows? Critical Review of the Field of Leadership Studies: From the ‘Great Man’& Trait Theory to Equity & Diversity Leadership in the Biodigital Era. Beijing International Review of Education, 5(1-2), 25-50.
- Oko-Otu, C. N., & Chidume, C. G. (2021). Objectivity and the great man theory in historiography. Cogito, 13(3), 124-138.