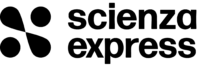Anche il termine “sovranità alimentare”, per lungo tempo riservato a esperti e attori sociali ed economici del sistema alimentare, soprattutto a livello internazionale, è diventato in tempi recenti di uso più comune. Questo processo, che vede inglobare nel linguaggio comune termini che provengono dal modo scientifico o da culture specialistiche – si pensi a “sostenibilità” o “resilienza” –, può essere visto con favore perché contribuisce ad arricchire la terminologia di tutti, ma soprattutto perché introduce nel sapere comune concetti prima di uso esclusivo; allo stesso tempo, però, potrebbe distorcere gli stessi concetti, trasformandoli in qualcosa di profondamente diverso. È utile quindi tornare alle origini del concetto stesso, non tanto per ingessarlo in una definizione, quanto per seguirne la possibile evoluzione, rispettandone il significato profondo nell’attualità. Secondo Wikipedia “La sovranità alimentare è un indirizzo politico-economico volto ad affermare il diritto dei popoli a definire le proprie politiche e strategie sostenibili di produzione, distribuzione e consumo di cibo, basandole sulla piccola e media produzione. Secondo i sostenitori della sovranità alimentare, le nazioni devono poter definire una propria politica agricola e alimentare in base alle proprie necessità, rapportandosi alle organizzazioni degli agricoltori e dei consumatori”.
La prima definizione di sovranità alimentare, formulata nel 1996 in occasione del Vertice mondiale sull’Alimentazione della FAO, si è evoluta sino alla Dichiarazione di Nyéléni del 2007, che ha coniato una definizione adottata quasi universalmente, secondo cui “La sovranità alimentare è il diritto dei popoli a un cibo sano e culturalmente appropriato, prodotto con metodi ecologicamente corretti e sostenibili, e il loro diritto a definire i propri sistemi alimentari e agricoli. Mette coloro che producono, distribuiscono e consumano cibo al centro dei sistemi e delle politiche alimentari piuttosto che le richieste dei mercati e delle aziende. Difende gli interessi e l’inclusione della prossima generazione”.
È importante, anche ai fini del confronto sulla governance di cui si dirà dopo, precisare che nel 2008 l’International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development (IAASTD), un panel intergovernativo cui partecipano anche le Nazioni Unite e la Banca Mondiale, ha confermato questa visione definendo la sovranità alimentare “come il diritto dei popoli e degli Stati sovrani a determinare democraticamente le proprie politiche agricole e alimentari“. Questo approccio – che potremmo definire come originario – alla sovranità alimentare trova origine in movimenti contadini che, in gran parte riuniti nella organizzazione internazionale de La Via Campesina, si oppongono alla globalizzazione del sistema alimentare mondiale originatasi durante e successivamente il processo definito come Rivoluzione Verde. Emerge quindi la contrapposizione tra locale e globale, e la valorizzazione delle culture alimentari locali, sia sotto il profilo alimentare e quindi delle diete, sia sotto quello dei metodi di coltivazione e di allevamento.
Politicamente quindi la sovranità alimentare ha fatto proprie le lotte contro l’accaparramento delle terre e contro gli OGM, e in genere contro la gestione delle risorse (naturali) locali. Infatti, per perseguire i diritti che vengono messi in luce dalla definizione di sovranità alimentare, è necessario che i popoli a livello locale possano gestire le proprie risorse: innanzitutto la biodiversità agraria, che è il risultato di una lunga coevoluzione tra piante, animali e uomini, e che spesso nel processo di globalizzazione viene sostituita da varietà internazionali coperte da brevetto, o anche direttamente brevettata da aziende sementiere internazionali. La gestione delle risorse locali riguarda anche altre risorse primarie per la produzione agricole come la terra – a volte al centro di operazioni predatorie definite come “land-grabbing” – e l’acqua, risorsa anch’essa al centro di contese tra istanze differenti.
Tuttavia, la contrapposizione dicotomica globale/locale è certamente riduzionistica. Per comprendere il panorama all’interno del quale si colloca oggi la sovranità alimentare è necessario allargare lo sguardo. Ad esempio, l’attivista francese José Bové de La Confédération Paysanne Européenne sottolinea la diversificazione dei modelli e delle risposte dei movimenti che si riconoscono nel concetto di sovranità alimentare. Di fronte alla complessità del mondo e dei fenomeni che compongono il food system è necessario fornire risposte a scale differenti: internazionale, nazionale e locale. L’idea originaria di sovranità alimentare si evolve in un più forte concetto di “autodeterminazione”, attraverso la quale le società possono autogovernarsi, riconoscendo il ruolo centrale dei produttori rurali e l’affermazione delle esigenze alimentari locali. Le risposte, di contro, possono essere funzionali alla crisi ecologica globale in corso, con obiettivi sociali e politici più ampi invocando quei diritti collettivi già riconosciuti dalle Nazioni Unite, come il diritto all’autodeterminazione, il diritto allo sviluppo e il diritto alla sovranità permanente sulle risorse naturali. Obiettivi che a loro volta vanno collocati nell’arena della governance internazionale, in un contesto di crisi – alimentare ma, molto più in generale, ambientale, climatica e geopolitica – globale.
La visione e il movimento per la sovranità alimentare oggi sono condizionati dai contorni del regime alimentare – ora in crisi, poiché la sua capacità di continuare a nutrire il mondo ha perso legittimità sulla scia della recente e continua crisi alimentare globale. Il sistema alimentare globale, secondo una dizione che accomuna governi, movimenti e organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite “is broken”. Le cifre sullo stato della nutrizione globale sono in questo senso un valido indicatore: più di 800 milioni di persone soffrono la fame, 676 milioni sono gli adulti obesi, 3 miliardi di persone non possono accedere a diete sane.
Se la crisi e l’analisi sono comuni, le risposte sul modello da adottare variano. Organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite, la FAO, ma anche la Banca Mondiale hanno recentemente dato vita al Food System Summit, proprio al fine di creare un sistema resiliente, capace di rispondere alla crisi contingenti – come quella pandemica, quella geopolitica e quella dei prezzi – ma soprattutto strutturali legate al cambiamento climatico, all’evoluzione demografica e al processo di urbanizzazione. Molte delle organizzazioni e dei movimenti che si riconoscono nei principi della sovranità alimentare si sono duramente opposte al Food System Summit , criticando in particolare il ruolo del World Economic Forum, legato alle corporation, e il ridimensionamento di meccanismi consolidati e rappresentativi della società civile come il Comitato per la Sicurezza Alimentare Mondiale della FAO e del Civil Society and Indigenous Peoples’Mechanism. In altre parole, la sovranità alimentare si auto configura come un movimento sociale e politico antitetico rispetto al ruolo di attori con un peso politico ed economico forte, in grado di influenzare le politiche di “sicurezza alimentare”, indirizzandole verso i principi del libero mercato. Il dibattitto intorno alla sovranità alimentare è ancora aperto. Non mancano le critiche di chi vede nella sovranità alimentare una forma di “populismo agrario”, ma sono certamente prevalenti le visioni che partendo dal concetto originario di sovranità alimentare intendono muovere una critica, offrendo una alternativa, al sistema alimentare globale.
Va sottolineato che la “sicurezza alimentare” è un concetto tecnico, mentre quello di sovranità alimentare è invece un concetto politico perché rivendica “una visione diversa su come pensare e praticare l’agricoltura proponendo di focalizzarsi sui sistemi di produzione locali, approfittando dei saperi e dell’agrobiodiversità dei territori e garantendo un accesso più equo alle risorse per produrre cibo d’accordo alle caratteristiche specifiche dei luoghi”[1]. In altre parole il dibattito intorno a questo concetto contiene semi di un potenziale riduzionismo, alimentato anche dalla crescente attenzione politica, in molti posti del mondo, al cibo, come dimostrano eventi quali la “rivolta dei trattori”, o il dibattito intorno alla carne coltivata o all’utilizzo di farine di insetti.
Cibo locale, autosufficienza alimentare, autarchia, sovranismo vs sovranità, povertà alimentare, diritto al cibo, democrazia alimentare, sono parole, idee, programmi che si articolano tanto sul piano tecnico, quanto su quello comunicativo e popolare. Concetti apparentemente progressisti come “sovranità alimentare” possono in questo contesto molto complesso e mutevole assumere significati differenziati e anche lontani da quelli originali. Vale la pena di parlarne per il tempo di un caffè e magari poi riservarsi il tempo di un pranzo per approfondire.
Davide Marino
Università del Molise
Dal nostro catalogo: Diritto al cibo, Il pianeta dei frigoriferi, All you can eat
[1]Isabella Giunta, Sovranità alimentare e politiche locali del cibo per superare la dipendenza? RE | Cibo, 1, 2022.