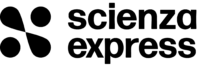Il 14 ottobre veniva data lettura di una lettera scritta il giorno 10 da Faugére, che aveva domandato privatamente a Chasles di aver copia della lettera di Pascal a Newton presentata il 30 settembre e di quella scritta dal re d’Inghilterra Giacomo II a Newton. Chasles, come al solito disponibile, gli aveva fatto avere i documenti il giorno stesso. Ebbene, Faugére era in grado di dire che anche questa ennesima lettera di Pascal non portava nulla alla tesi di Chasles. Inoltre, aveva comparato il presunto autografo del re inglese con una sua lettera sicuramente autentica conservata al Ministero degli Esteri, scoprendo che le grafie erano completamente diverse. Era sempre più urgente, concludeva, una verifica di tutto il materiale in possesso del matematico.
Secondo Chasles, che prese subito la parola, Faugére criticava senza addurre alcuna prova positiva. La lettera del re inglese era autentica, ma chi poteva dire che fosse anche autografa? Era infatti costume dei sovrani far redigere da segretari e copisti le proprie corrispondenze ufficiali. Egli ribadiva di voler pubblicare tutto il materiale in suo possesso per dissipare ogni dubbio. Si augurava che anche tutti coloro che avevano espresso dubbi facessero altrettanto e che si facessero assistere da veri esperti invece di trarre conclusioni su materie delle quali non erano specialisti. Tornava poi a parlare della provenienza dei suoi documenti, in gran parte giunti dal fondo Desmaizeaux, passati più volte di mano, alla fine gli erano stati offerti da una nobile famiglia francese che pensava che ne avesse fatto buon uso [in realtà la corrispondenza di Desmaizeaux, una delle più importanti del XVIII secolo, era stata dispersa in vari paesi (Londra, Leida, Copenhagen, Ginevra), ma Chasles era male informato, forse dallo stesso Vrain Lucas].
Prendeva poi la parola il generale Morin, che confermava l’uso da parte del re Luigi XIV di servirsi di diversi delegati in grado di imitare la sua scrittura per redigere ordini o documenti per i vari affari di stato. L’usanza era comune a tutti i sovrani: un punto a favore di Chasles.
Era il turno di Le Verrier, piuttosto indignato per le offese che a suo dire erano state fatte all’onore di Newton nei documenti presentati da Chasles. Il grande astronomo metteva in risalto come le lettere attribuite a Pascal e Galileo, il cui unico valore era quello di giustificarsi a vicenda, facevano credere che Newton avesse ricevuto delle osservazioni astronomiche e dei calcoli da Pascal, mentre egli stesso, in due luoghi diversi dell’edizione del 1726 dei Principia, attribuiva tale merito a Cassini. Ora, mentre non c’era traccia dei calcoli di Pascal al di fuori dei documenti presentati da Chasles, e solo da lui, i calcoli di Cassini, nonché la descrizione degli strumenti utilizzati, erano proprio agli atti dell’Accademia! Le Verrier esprimeva molti dubbi sull’autenticità delle lettere presentate, particolarmente riguardo a quelle di Galileo.
Il 28 ottobre Chasles interveniva subito per rispondere alle critiche di Brewster del 30 settembre sull’autenticità delle lettere attribuite a Newton e Pascal. Naturalmente, il lettore che ha seguito fin qui la vicenda l’avrà intuito, lo fece mettendo a disposizione del consesso due nuove serie di lettere, del re inglese Giacomo II e di quello francese Luigi XIV a vari interlocutori, che a suo dire avrebbero chiuso la questione.
Chasles spiegava che all’origine degli scambi epistolari che coinvolgevano i due sovrani c’era una lettera di Newton a Huygens, anteriore al 1664, in cui lo scienziato inglese si lasciava andare a giudizi poco lusinghieri su Cartesio e Pascal. La lettera fu vista da Claude Clerselier, amico, seguace ed editore di Cartesio, che ne parlò a Mariotte, suscitando l’ira dei geometri francesi. Informato, Huygens avrebbe scritto a Newton invitandolo a ritrattare i suoi giudizi e a chiedere scusa. Newton non lo fece e omise di citare Pascal quando uscì la sua opera nel 1687. Sorsero in Francia nuove lamentele, che giunsero all’orecchio di re Luigi, che scrisse direttamente a Huygens, allora esule in Olanda dopo la revoca dell’editto di Nantes, invitandolo a tornare a Parigi dove aveva vissuto per quindici anni. Gli chiedeva anche di poter vedere la lettera incriminata. Huygens, malato, non poteva viaggiare, ma fece avere al re una lettera di risposta con il racconto della giovinezza di Newton e delle sue relazioni con Pascal. Pur non avendo potuto leggere la lettera di Newton, il re francese scriveva allora a Huygens per ringraziarlo. Successivamente, durante una visita di stato del re inglese, lo informava del malcontento degli ambienti scientifici di Parigi nei confronti di Newton. Giacomo II scrisse allora a Newton. Quest’ultimo scrisse allora nel settembre 1689 a Luigi XIV per scusarsi e per riconoscere il suo debito verso Pascal. Tutta questa corrispondenza veniva depositata agli atti dell’Accademia. Nell’annunciare di possedere decine di altri documenti simili, Chasles concludeva che Brewster, Grant e, soprattutto, Faugére dovevano smetterla di evocare complotti e ammettere la grandezza di Pascal. di informarsi se tra i manoscritti conservati al British Museum e tra le raccolte private dei Lord Portsmouth e Macclesfield ci fossero tracce dei rapporti tra Pascal e Newton. Dal British Museum lo avevano informato che una parte del fondo lasciato da Desmaizeaux era presso di loro e riguardava gli anni dal 1698 fino alla sua morte. Tra i documenti erano presenti delle lettere di Leibniz sulla sua controversia con Newton [sulla paternità nello studio del calcolo infinitesimale], ma nient’altro. Non c’era stata invece stata alcuna risposta da parte dei due nobiluomini. Egli era comunque certo che presso di loro non vi era alcuna testimonianza dei rapporti tra Pascal e Newton. Continuava la sua ricerca e annunciava comunque che avrebbe presto prodotto le prove che il falsario autore delle lettere possedute da Chasles era Desmaizeaux
Gongolante, Chasles prendeva atto della correttezza di Brewster e commentava che, possedendo egli stesso delle lettere di Desmaizeaux sulla controversia tra Pascal e Newton, e di Leibniz su quella con lo stesso Newton, era possibile finalmente confrontare le documentazioni senza più accuse di falsificazioni.
L’11 novembre veniva letta una lettera di Brewster a Le Verrier, datata 2 novembre, riguardante le relazioni tra Giacomo Cassini e Newton. Si trattava di una nota che Cassini aveva scritto a Newton, nella quale gli comunicava le effemeridi calcolate dal padre Gian Domenico, dei cinque satelliti di Saturno, poco diverse da quelle pubblicate da Newton nella seconda edizione dei Principia. Il documento, secondo l’inglese, era una eloquente testimonianza che sui dati astronomici, e su molto altro, Newton nulla doveva a Pascal.
________________________________
Le effemeridi sono tabelle astronomiche usate per determinare la posizione di oggetti celesti in un dato tempo. Esse contengono valori calcolati, nel corso di intervalli prefissati ed equidistanti fra loro, per esempio di giorno in giorno oppure di ora in ora, di diverse grandezze astronomiche variabili, come: magnitudine, parametri orbitali, coordinate, distanza di pianeti, comete, asteroidi e satelliti artificiali.
________________________________
Seguiva poi un’altra lettera di Brewster, del 6 novembre, indirizzata al Presidente dell’Accademia riguardante i documenti attribuiti a Pascal e a Newton. Chasles aveva assicurato che provenivano dall’archivio di Desmaizeux, perciò dovevano essere stati in suo possesso tra il 1727, anno della morte di Newton, e il 1740, anno in cui morì. Desmaizeaux tra il 1734 e il 1740 era stato un attivo collaboratore del Dictionnaire Général. Egli avrebbe potuto comunicare informazioni importanti e originali sui grandi personaggi che erano stati in rapporto con lui. Ebbene, nelle estese biografie di Pascal e di Newton (comprese diverse lettere) pubblicate da quell’organo non esisteva alcuna menzione dell’estraordinarie “novità” in campo scientifico comunicate da Chasles. Quest’ultimo avrebbe dovuto spiegare con la sua abituale destrezza questa suppressio veri attuata da Desmaizeaux ai danni di suoi due compatrioti come Cartesio e Pascal. Brewster ricordava infine la testimonianza degli esperti inglesi che non esisteva alcuna corrispondenza tra Pascal e Newton e che, secondo il signor Bond, la presunta lettera di Leibniz a Desmaizeaux non era assolutamente di Leibniz.
Il Presidente Balard, conclusa la lettura delle lettere di Brewster, invitava Chasles a pubblicare integralmente e al più presto i suoi documenti e le sue osservazioni, astenendosi dal rispondere direttamente. Si augurava inoltre che Chasles non esaurisse in quella polemica la sua salute e il suo prestigio.
Niente da fare: il matematico non era tipo da incassare senza repliche. Brewster non aveva aggiunto niente a quanto detto in precedenza da lui stesso e da Le Verrier sulla provenienza dei dati utilizzati da Newton. Quanto alle informazioni in possesso di Desmaizeaux che egli non avrebbe utilizzato nel Dictionnaire, la risposta era già stata data nei documenti già presentati: Desmaizeux aveva già mostrato a varie persone, soprattutto a Montesquieu, le lettere di Newton e desiderava non tornare sull’argomento, volendo preservarne l’onore. E poi, come poteva Brewster fidarsi di Desmaizeaux, che la settimana precedente aveva accusato di essere l’autore dei presunti falsi? Chasles dichiarava di essere stanco che fosse messa in dubbio la sua onestà: egli aveva parlato tramite i documenti che aveva presentato e con altri, tutti in suo possesso, aveva risposto alle critiche. La sua “abituale destrezza” consisteva nel voler dimostrare la verità. Desiderava ricordare, a proposito dei giudizi sulle calligrafie espressi da Bond, Brewster e Faugére, che quei signori non erano degli esperti. Aveva infine saputo di una lettera fatta pervenire a Le Verrier da Grant e che era stata messa agli atti, ma si riservava di replicare nella seduta successiva.
La lettera cui faceva riferimento Chasles era stata scritta a Glasgow il 31 ottobre da Robert Grant. L’astronomo tornava sulle presunte lettere di Galileo a Pascal che avrebbero indicato il pisano come origine delle sue rivoluzionarie idee sulla meccanica celeste. Grant esaminava punto per punto i dati astronomici che avrebbero consentito a Galileo di intuire e a Pascal di dimostrare la legge di gravitazione già nel decennio centrale del Seicento. Ne concludeva che, data la strumentazione allora disponibile, era impossibile che essi potessero disporre di dati precisi riguardo: a) il diametro apparente del Sole, di Giove e di Saturno; b) i periodi di rivoluzione dei satelliti di Giove (determinati con sufficiente precisione solo nel 1719 da Bradley e Pound); c) i periodi di rivoluzione dei satelliti di Saturno (che Galileo, contrariamente a quanto affermato da Chasles, proprio non conosceva); d) la parallasse solare (determinata da Cassini intorno al 1670). C’era inoltre un fatto che avrebbe impedito a Galileo ogni ulteriore scoperta nella parte finale della sua vita: egli era diventato cieco, com’è testimoniato da più contemporanei, già dal 1637! I dati utilizzati da Newton erano stati disponibili molti anni dopo la morte di Pascal. I documenti presentati all’Accademia e attribuiti a Galileo, Pascal e Newton erano da considerare delle pure contraffazioni, così come era lecito immaginare che lo fossero, data la loro origine comune, tutti gli scritti presentati da Chasles.
________________________________
Con il nome di parallasse si indica lo spostamento o differenza nella posizione apparente di un oggetto visto lungo due diverse linee di vista e viene misurata dall’angolo o semiangolo di inclinazione tra queste due linee. A causa della differenza di prospettiva, gli oggetti vicini mostrano una parallasse maggiore rispetto agli oggetti più lontani, quindi la parallasse può essere utilizzata per determinare le distanze.
Per misurare grandi distanze, come la distanza di un pianeta o di una stella dalla Terra, gli astronomi utilizzano il principio della parallasse. Se l’oggetto celeste è molto lontano, l’angolo da misurare è piccolissimo (frazioni di grado) e va misurato con estrema precisione per non incorrere in errori anche grossolani nella risoluzione trigonometrica del triangolo.
La parallasse orizzontale equatoriale media del Sole o, più semplicemente, la parallasse solare è una costante astronomica del Sistema Astronomico di Unità dell’Unione Astronomica Internazionale (IAU). È definito come l’angolo piano sotteso dal raggio equatoriale della Terra alla distanza di un’unità astronomica di lunghezza.
________________________________
La seduta dell’Accademia del 18 novembre si apriva con la lettura di una nota inviata ancora da Brewster a Chevreul il giorno 14. Egli riteneva che il falsario fosse Desmaizeaux e allegava un breve appunto di Lord Portsmouth che confermava che tra i documenti autografi di Newton da lui posseduti non c’era traccia di rapporti tra lo scienziato inglese e Pascal.
Interveniva poi Chasles, per replicare alla lettera di Robert Grant. Il punto su cui desiderava iniziare era la presunta cecità di Galileo nell’anno, il 1641, in cui inviò le lettere a Pascal che erano state presentate il 7 ottobre. Probabilmente Grant si riferiva al rapporto inviato al Papa dall’inquisitore di Firenze dopo una visita di controllo nella casa di Arcetri dove viveva recluso l’ormai settantacinquenne scienziato, lettera in cui si diceva che Galileo era affetto da cataratta, era completamente cieco, ma sperava di guarire. Chasles era in grado di portare a conoscenza dei colleghi altri documenti, in cui si dimostrava che Galileo perdette la vista solo negli ultimi mesi del 1641. Si trattava di alcune lettere di Viviani, amico e discepolo di Galileo, a Pascal, di due lettere di Galileo a Pascal e poi altre corrispondenze di Boulliau con Huygens, con Flamsteed, con Cassini, con Desmaizeaux. Vi erano anche tre nuove lettere di Newton. Un nuovo mare di carte per sommergere le contestazioni, tutto teso a dimostrare che la perdita della vista di Galileo fu progressiva e si completò solo poco prima della morte avvenuta l’8 gennaio 1642 e che il pisano aveva fornito osservazioni corrette un po’ a tutti, tra i quali Pascal, del quale conosceva l’opera e i meriti.
Marco Fulvio Barozzi