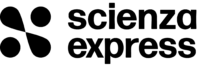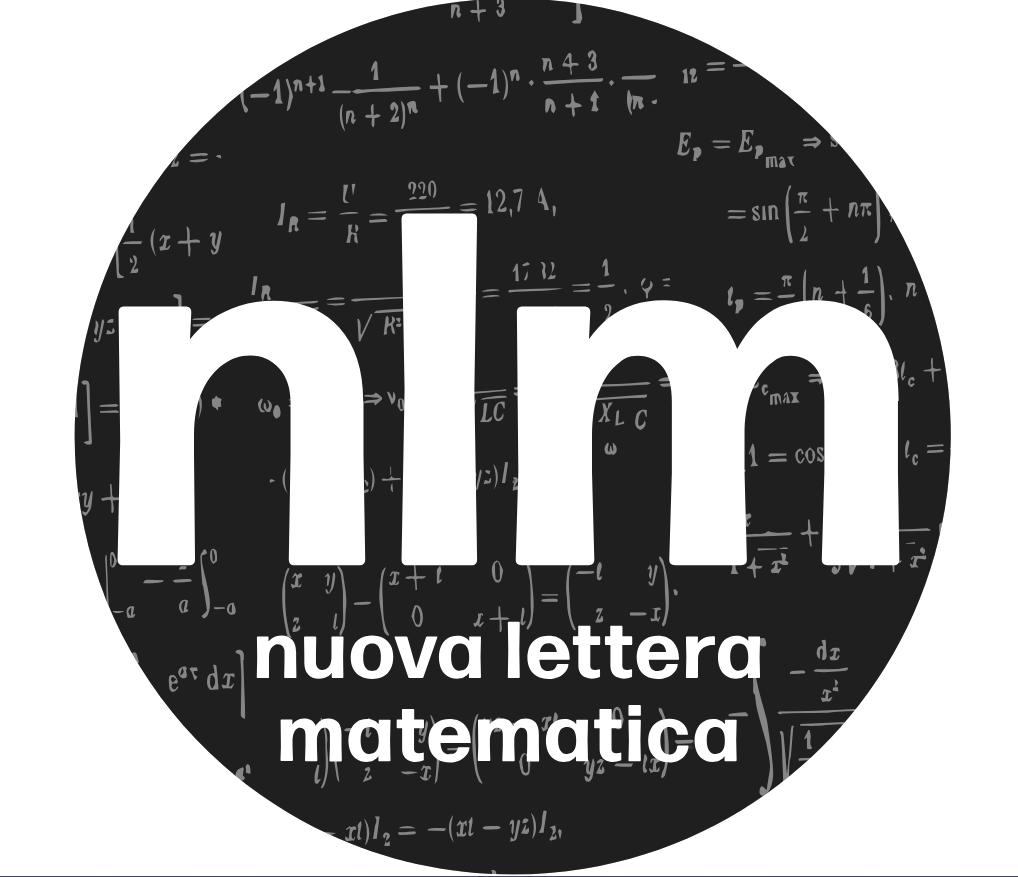La riforma Gentile, entrata in vigore nel 1924, fu molto controversa e ha condotto a nefaste conseguenze sulla scuola italiana. Ideata dal filosofo Giovanni Gentile, la riforma si basava su principi della filosofia idealista e privilegiava l’istruzione classica rispetto a quella tecnico-scientifica. Dopo la legge Casati, che aveva stabilito l’assetto scolastico del neonato Regno d’Italia, la riforma Gentile mirava a razionalizzare il sistema scolastico, eliminando classi aggiuntive e riducendo il numero di insegnanti precari.
Ma chi è Giovanni Gentile? Figura controversa, Gentile è un brillante filosofo, ex normalista, nominato professore a Palermo e poi dal 1917 a Roma. Prima della marcia su Roma (1922) non sembra interessarsi alla politica, ma nel maggio 1923 aderisce al fascismo con una lettera inviata direttamente a Mussolini, il quale lo nomina, all’insediamento del regime, ministro della pubblica istruzione.
La riforma Gentile semplificava l’accorpamento delle diverse discipline, abbinando materie affini, e introduceva esami centralizzati per valutare gli studenti. Lo scopo era creare una struttura gerarchica e centralizzata, allineata con l’ideologia fascista.
Più nei dettagli, la riforma prevedeva essenzialmente due percorsi:
- liceo classico (cinque anni di ginnasio e tre di liceo), destinato all’élite e orientato alla formazione umanistica;
- istruzione tecnica, concepita per fornire competenze professionali immediate.
Le discipline scientifiche erano relegate all’istruzione tecnica e ricevevano un riconoscimento culturale ridotto. Il liceo scientifico, pur istituito, risultava marginale, privo di un ciclo preparatorio e con un programma debole in matematica e fisica.
La riforma introduceva anche il liceo femminile, pensato per formare le giovani donne al ruolo di madri e mogli, senza offrire sbocchi professionali né accesso agli studi superiori. L’istituto magistrale, invece, preparava gli insegnanti con un percorso di quattro anni più tre di specializzazione.
Come diretta conseguenza della riforma, si assiste a una progressiva svalutazione delle scienze matematiche e fisiche rispetto alle discipline umanistiche. Una forte opposizione alla riforma venne dalla comunità scientifica, in particolare da Federigo Enriques, matematico e promotore della cultura scientifica in Italia. Enriques organizzò il Primo congresso dei filosofi italiani nel 1906 e fondò la Società Filosofica Italiana e la rivista Scientia, con l’obiettivo di dare maggiore spazio alla scienza. Tuttavia, Gentile e Benedetto Croce si mobilitarono per ridurre l’influenza degli scienziati nei congressi successivi, sancendo la supremazia della filosofia idealista. Anche le associazioni degli insegnanti di matematica, in particolare la Mathesis, si opposero alla riforma Gentile senza tuttavia riuscire, nei fatti, a ostacolarne la messa in opera. Tra le società intellettuali, fu soprattutto l’Accademia dei Lincei, sotto la presidenza di Vito Volterra, a criticare duramente la riforma, temendo un ritorno a un sapere basato sull’umanesimo piuttosto che sulle discipline scientifiche. Particolarmente critico fu il matematico Guido Castelnuovo, collega di Enriques e Volterra all’Università di Roma, che si esprime anche contro l’accorpamento della storia con la filosofia o della matematica con la fisica, che avrebbe la conseguenza di abbassare il livello di insegnamento oltre che impedire il dialogo tra i diversi punti di vista. Infine, è anche critico contro gli esami di stato, anche questi introdotti nella riforma, che secondo Castelnuovo potrebbero condurre a ricette pratiche appositamente confezionate per ottenere la promozione a discapito di un apprendimento più ampio e articolato.
Quasi nessuna resistenza, invece, venne dalla società che avrebbe dovuto preservare gli interessi della comunità matematica italiana, ossia l’Unione Matematica Italiana (UMI) che non prese una posizione netta, limitandosi a riferire i termini della questione sul suo Bollettino. Alcuni matematici, come Gaetano Scorza, collaborarono con Gentile nella stesura dei programmi scolastici, senza opporsi concretamente alla riforma.
Dopo le sue dimissioni da ministro, la carriera accademica di Gentile procedeva comunque velocemente. Nel 1925 inaugurava l’Istituto Fascista di Cultura e diveniva il direttore del grande progetto dell’Enciclopedia Italiana. Nel 1932 veniva eletto socio nazionale dell’Accademia dei Lincei e nel 1943 presidente della Regia Accademia d’Italia, la società fondata da Mussolini e controllata dal governo fascista. Rimasto una figura centrale nel panorama accademico e culturale, Gentile aderiva alla Repubblica Sociale Italiana e fu assassinato a Firenze nel 1944 dai partigiani.
La sua celebre riforma fu soggetta a modifiche progressive, culminando nella Carta della Scuola del 1939 e influenzando il dibattito educativo per decenni. Lasciava un segno indelebile nella scuola italiana che visibile ancora oggi nella malsana separazione tra cultura umanistica e scientifica e nella predominanza della prima sulla seconda.
Rossana Tazzioli
Laboratoire Paul Painlevé, Université de Lille (France)
Sintesi di Rossana Tazzioli, La verità matematica è “morta, infeconda, arida come un sasso”[1]. Nuova lettera Matematica n.2 Nuova Serie pp. 54-63.
[1] G. Gentile, 1912, Sommario di pedagogia come scienza filosofica, II, Didattica, Firenze, Sansoni, (V ediz.) 1955, p. 183
Scarica l’articolo completo apparso sulla rivista Nuova Lettera Matematica.