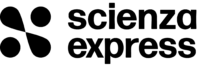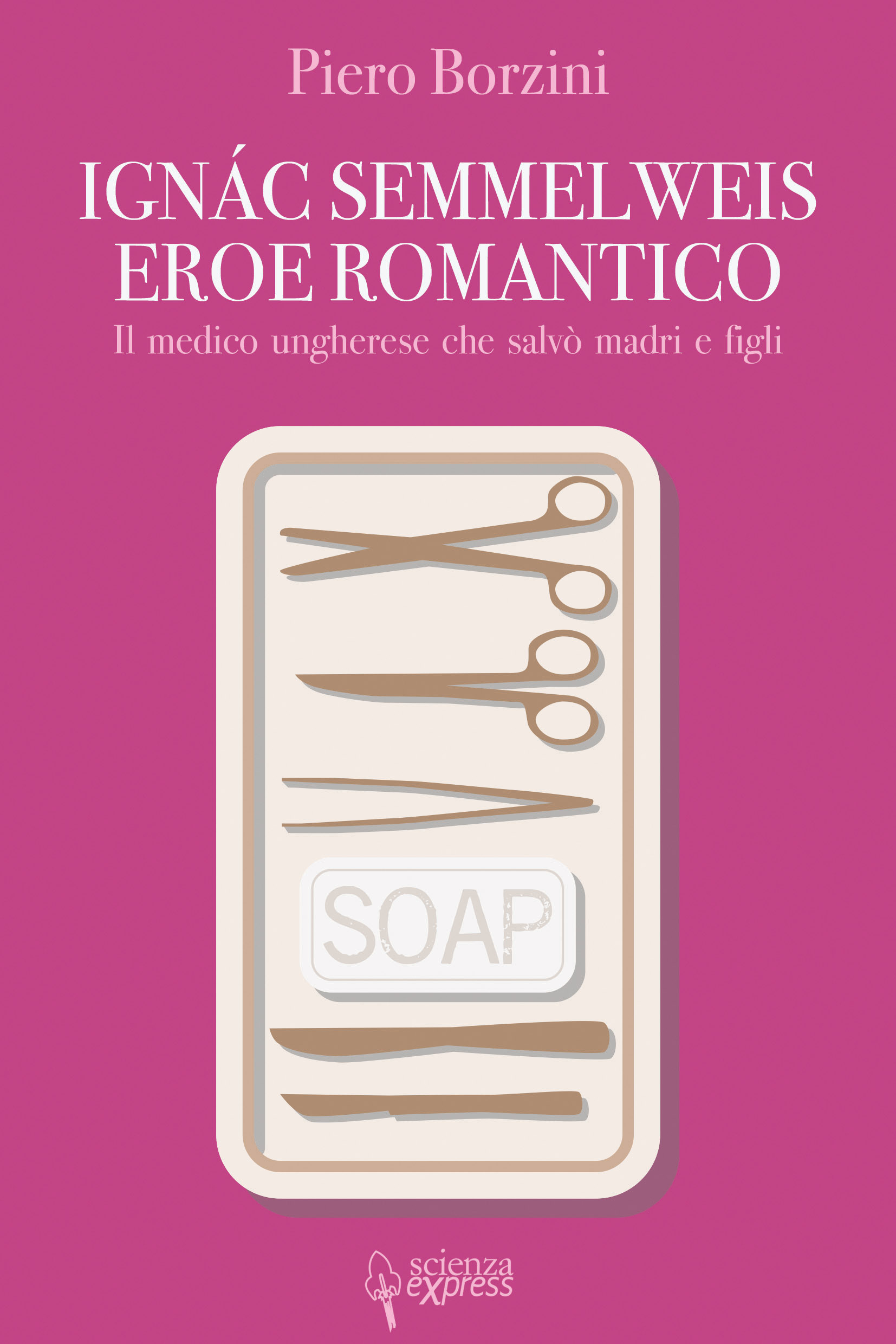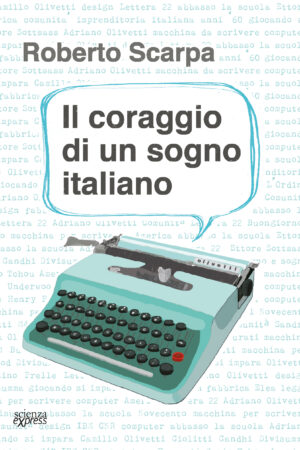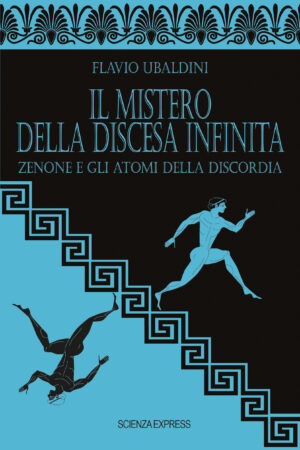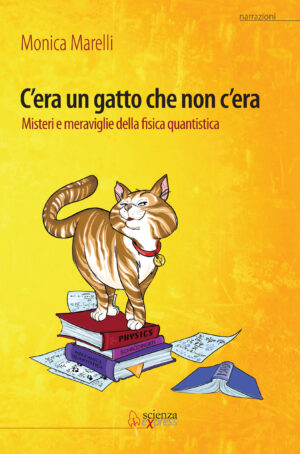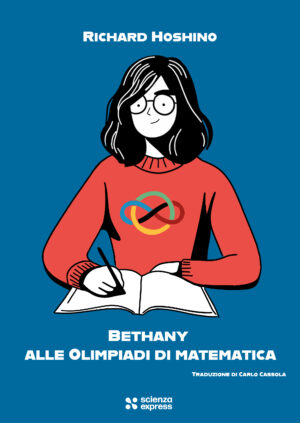Piero Borzini
Ignác Semmelweis, eroe romantico
Semmelweis è giustamente passato alla storia con le stigmate dell’eroe per il suo enorme contributo alla medicina, quasi un santo che ha combattuto fino all’estremo sacrificio contro gli ottusi poteri contrari ad accogliere le sue tesi e le sue pur efficacissime misure profilattiche. Tuttavia c’è di più. Come altri eroi della scienza, Semmelweis lo è diventato suo malgrado. Si è trovato in una frattura della storia: quei momenti di passaggio tra un’epoca e l’altra, in cui le vecchie idee si scontrano con le nuove; in cui la grande storia (quelle degli imperi e delle nazioni) si intreccia con le piccole storie delle persone; dove i vecchi paradigmi scientifici, politici, e ideologici traballano sotto la spinta dei nuovi paradigmi e delle nuove ideologie. È lì in mezzo che Semmelweis venne a trovarsi: a metà del guado e tra i due fuochi, tra la vecchia medicina galenica e ippocratica e la nuova medicina scientifica, che la incalzava da presso. Semmelweis si schierò decisamente per il nuovo e il suo operato (a saperlo guardare) fu la dimostrazione chiara ed evidente dei meravigliosi frutti che la medicina clinica poteva ottenere abbracciando la nuova metodologia scientifica. Ma l’ambiente non fu propizio, e i tempi prematuri. Le sue idee furono rifiutate; lui stesso fu rifiutato come persona. D’altra parte, anch’egli – incapace di condurre relazioni umane serene – commise indicibili errori (nei toni e nell’approccio scientifico) che vanificarono ogni suo sforzo e per i quali pagò duramente. Ma chi pagò di più furono le migliaia di donne che, a un passo dalla possibile salvezza, furono respinte indietro dall’incomprensione e dallo scontro tra un nuovo che avanzava troppo in fretta e un vecchio che non sapeva adeguarsi.
Quarta di copertina

Piero Borzini, durante la carriera ospedaliera dedicata all’immunologia, al trapianto e alla medicina rigenerativa, non ha trascurato gli aspetti storici, filosofici e antropologici del suo mestiere. Ritiratosi dall’attività clinica, ha continuato a coltivare tali aspetti. Ha pubblicato: Immunologia, evoluzione, pensiero (Roma, 2009); Diventare umani (Roma, 2013); William Bateson, l’uomo che inventò la Genetica (Milano, 2015); Non fare troppe domande: i classici della narrativa distopica per una discussione sulla libertà (Milano, 2016); L’arduo cammino di Darwin. Costruzione di una teoria rivoluzionaria (Milano, 2019). Pubblica articoli e recensioni per Methodologia-on-line e per Filosofia e Nuovi Sentieri (rivista on-line). Sul blog Dove osano le galline pubblica post su “Scienza e società”.