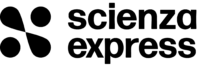Il Teorema di Talete è uno dei più semplici e più noti teoremi che si imparano a scuola. È stato realmente dimostrato da Talete? In quale fra le sue opere? In realtà non esiste nessuna informazione diretta o indiretta che ci porti a collegare questo teorema con la figura storica di Talete, sempre ammesso che si possa considerare storico un personaggio che si perde nel mito come Talete di Mileto (VII-VI secolo a. C.). Le notizie che abbiamo oggi riguardanti il famoso filosofo sono molto generiche e tutte di seconda o terza mano. Nessuna opera di Talete è sopravvissuta e non ci rimane con certezza nemmeno il titolo di qualche suo scritto. I frammenti attribuiti a Talete nell’antichità sono molto dubbi, tanto che perfino gli storici antichi, come Plutarco, ritenevano che fossero falsi. Erodoto, Platone e Aristotele, che nominano Talete in qualche passo, non avevano a disposizione nessun testo originale. È lecito a questo punto dubitare che Talete abbia scritto qualcosa; oppure, nel caso in cui siano effettivamente esistite opere scritte da Talete, sono andate perdute molto presto, già nel V secolo a. C. Allora che senso ha attribuire a Talete il teorema che porta il suo nome?
Nel corso della storia, molti teoremi diversi sono stati attribuiti a Talete, soprattutto nei libri di testo. Ad esempio, il secondo criterio di congruenza fra triangoli e il teorema secondo il quale un triangolo inscritto in una semicirconferenza è rettangolo. Nei libri tedeschi si diffonde proprio quest’ultimo teorema; a partire dal XIX secolo l’attribuzione dilaga fino a raggiungere la maggior parte dei libri di matematica scolastica; successivamente anche in Austria, Ungheria e Cecoslovacchia il Teorema di Talete è quello del triangolo inscritto in una semicirconferenza. In Francia e in Italia il Teorema di Talete riguarda un insieme di rette parallele tagliate da due secanti. L’attribuzione nasce nei libri di testo italiani e francesi e successivamente si diffonde anche in Spagna, Belgio, Russia.
È possibile far risalire una di queste attribuzioni all’antichità? La risposta è no. Plutarco, e Plinio dichiarano che Talete aveva misurato l’altezza delle piramidi di Giza, senza specificare di quale teorema avesse fatto uso. Più specifico è Diogene Laerzio, che a proposito di Talete parla del triangolo rettangolo inscritto in una circonferenza, citando come sua fonte il filosofo Ieronimo di Rodi. Infine, Proclo attribuisce a Talete alcuni teoremi, che non coincidono con quello a noi noto. È opportuno sottolineare che Proclo è vissuto circa un millennio dopo Talete, e non ci racconta quali siano le sue fonti (ammesso che ne abbia effettivamente avuta qualcuna). Per inciso, ricordiamo che in Euclide non è presente il teorema come noi lo conosciamo, ma una sua variante: se una retta parallela a un lato di un triangolo taglia gli altri due lati, essa individua su di essi segmenti proporzionali (Elementi, VI, 2). Dunque a quando risalgono i primi testi che attribuiscono a Talete il teorema che tutti conosciamo? In Francia il primo caso noto è del 1882, in Italia del 1885 (Enrico d’Ovidio, Teoria analitica delle forme geometriche fondamentali, Lezioni date nella Regia Università di Torino, Loescher, Torino). Più o meno agli stessi anni risale l’attribuzione a Euclide dei teoremi che in tutti i libri di testo portano il suo nome.
La storia della scienza propriamente detta nasce nel XIX secolo, ma fino a pochi decenni fa è stata genericamente basata su illazioni. Un esempio eclatante, fra gli altri, è Men of Mathematics di Eric Temple Bell, stampato per la prima volta nel 1937, dove l’autore inventa di sana pianta caratteri, episodi, dialoghi, come nel caso della biografia di Galois o di quella di Cantor. Il motivo principale per cui la storia della scienza è stata a lungo incurante della fedeltà ai fatti reali si spiega con l’obiettivo che gli storici si erano prefissati: questo obiettivo non era capire come si è sviluppata la scienza e ricostruire gli eventi cardine che hanno portato alla nascita di idee rivoluzionarie, bensì fornire esempi luminosi e delineare modelli da seguire. In sostanza, un intento pedagogico e non scientifico. In moti testi classici di storia della scienza, infatti, sono frequenti espressioni del tipo «è difficile immaginare che … non sia riuscito a dedurre questo risultato», oppure «è certo che avrebbe potuto congetturare che…».
Ecco cosa dice Temple Bell nella biografia di Gauss: «… (Gauss) entrò nella sua prima scuola, un sordido vestigio del Medioevo tenuta da un bruto, un certo Büttner. Il suo unico metodo di insegnamento con il centinaio di bambini che gli venivano affidati era di terrorizzarli a tal punto che dimenticavano perfino il proprio nome; un’altra caratteristica, questa, del buon tempo antico, dietro al quale i sentimentali conservatori sospirano ancora.» Il compito che il bruto affidò alla classe, secondo l’autore, era «addizionare 81297 + 81495 + 81693 + … 100899. (…) Verso la fine della sua vita, Gauss si divertiva molto a raccontare questo aneddoto.» Inutile aggiungere che il personaggio di Büttner, il compito assegnato, la soluzione trovata da Gauss, i racconti della sua tarda età sono tutti inventati. I primi biografi di Gauss, subito dopo la sua morte, non parlano di questo episodio, semplicemente perché è un falso.
Una volta chiarito che l’obiettivo della storia della scienza nell’800 non è la fedeltà storica, cerchiamo di capire come mai alla fine del secolo i manuali scolastici francesi e italiani introducono la dicitura Teorema di Talete. I motivi che possiamo congetturare sono essenzialmente tre. Il primo, esaltare il valore di un personaggio indicandolo come autore di una scoperta importante. Il secondo motivo, speculare del precedente, è sottolineare l’importanza di un certo risultato legandolo al nome di un personaggio già famoso. Il terzo motivo, importante per la didattica, è aiutare la memorizzazione di un teorema legandolo al nome di un personaggio noto. Una volta che un’attribuzione è stata introdotta, tutti i testi successivi copiano i precedenti e il nome del teorema si diffonde in modo inarrestabile. Il caso del Teorema di Talete, come molti altri, rientra nell’ambito della Legge dell’eponimia di Stigler: «a una scoperta scientifica non si dà mai il nome del suo autore.» Stephen Stigler, coerentemente con la legge stessa, ci informa che la legge che porta il suo nome è stata enunciata in precedenza da Robert K. Merton.
Carlo Càssola
Liceo Scientifico “Copernico”, Udine
Per saperne di più
The Theorem of Thales: A Study of the Naming of Theorems in School Geometry Textbooks, pubblicato in The International Journal for the History of Mathematics Education, Vol. 1, n. 1, 2006
Nel nostro catalogo: Geometria piana per le gare di matematica, Problem solving in geometria, Le geometrie oltre Euclide