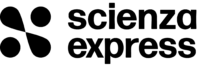Il 2 dicembre Il presidente comunicava di aver ricevuto un’altra nota di Brewster, che allegava una lettera comparsa sul Times il 21 novembre. Tale lettera, inviata da Gilberto Govi, professore di fisica all’Università di Torino, e riguardante i presunti autografi di Galileo, veniva allegata agli atti. Govi, fisico e storico della scienza, esperto di Galileo, era piuttosto apodittico: si trattava di falsi. In primo luogo perché erano scritte in francese, lingua che Galileo non conosceva. Tra i suoi manoscritti non c’è una sola riga scritta in francese ed egli, quando corrispondeva con degli stranieri, compresi dei francesi come Gassendi o Boileau, usava l’italiano o il latino. Inoltre, i suoi numerosi allievi e biografi, che non avrebbero perso occasione di accrescerne la gloria, non hanno mai fatto cenno a questa conoscenza. Ma c’era di più: le lettere presunte di Galileo erano datate da Firenze, ma dal 1633 viveva ad Arcetri in esilio nella villa concessagli dalla famiglia Martellini. In 8 anni scrisse 93 lettere, tutte da Arcetri, tranne una da Firenze il 7 agosto 1638, diretta a Elia Diodati, quando ebbe un permesso provvisorio dell’Inquisizione per recarsi nella sua piccola residenza fiorentina. Quanto alla cecità di Galileo, essa era grave al punto di consentirgli neanche la percezione della luce, era cominciata già nel 1632, come risulta dalle Opere Complete, ed era testimoniata anche nella lettera dell’inquisitore letta da Chasles, che si basava su una traduzione imprecisa dall’italiano “L’ho ritrovato privo di vista e cieco affatto”, ripetuta in un’altra lettera dello stesso inquisitore “… ritrovandosi Egli totalmente cieco, e più con la testa nella sepoltura che con l’ingegno agli studi matematici”. Galileo che non sapeva il francese, che era ad Arcetri e non a Firenze, che dal 1637 era completamente cieco: erano troppi i dubbi sollevati dalle lettere in possesso di Chasles, che andavano ad aggiungersi a quelli espressi da altri sulle sue conoscenze astronomiche, quali la scoperta dei satelliti di Saturno, che nessuno ai suoi tempi era in grado di distinguere. Govi invitava poi Chasles a confrontare le sue 5 lettere con quelle autentiche, ad esempio quella scritta da Galileo al principe Cesi, fondatore dell’Accademia dei Lincei, della quale doveva possedere una copia.
________________________________
Gilberto Govi (1826 – 1889) è stato un fisico, accademico e patriota italiano.
Laureato all’Università di Padova, nel 1848 entrò a far parte dell’Esercito Sardo e combatté durante la Prima Guerra d’Indipendenza, poi fu costretto a fuggire in Francia dove approfondì i suoi studi scientifici. Nel 1855 fu nominato dal granduca di Toscana commissario all’Esposizione universale di Parigi e nel 1857 divenne grazie a lui professore di fisica tecnologica presso l’Istituto Tecnico Toscano.
Nel 1859 partecipò nuovamente nelle file dell’esercito sardo alla seconda guerra d’indipendenza italiana. L’anno dopo divenne docente della cattedra di fisica sperimentale dell’Università di Torino. Nel 1878 ottenne dall’Università Federico II di Napoli la cattedra di fisica sperimentale e quindi la direzione del Gabinetto di Fisica. Qui studiò la fluorescenza sulla luce polarizzata e il comportamento del caucciù vulcanizzato a diversa temperatura.
Negli ultimi anni studiò gli effetti dell’elettricità e del magnetismo; inventò un barometro ad aria, il termometro registratore a gas; volle anche rivolgere il suo interesse alla figura di Leonardo da Vinci, in particolare al suo Codice Atlantico. Divenne anche esperto di storia della scienza, per la quale propose invano un corso universitario.
________________________________
Quest’ultima frase suscitava l’ira di Chasles, che dichiarava che non poteva essere verbalizzata una così bassa e grave insinuazione [Govi avrebbe parlato di un malinteso in una nota messa agli atti nella seduta successiva].
Il 9 dicembre veniva depositato un estratto di una lettera di Pieter Harting (1812-1885) a Le Verrier, nel quale il medico e naturalista olandese intendeva difendere l’onore del connazionale Huygens, vero scopritore del primo satellite di Saturno, dalle dichiarazioni mendaci fatte da Chasles nella seduta in cui aveva attribuito a Galileo questa scoperta. Esistevano numerose prove scritte, alcune dello stesso Huygens, che non potevano essere smentite. Inoltre, all’Università di Leida era ancora conservato il telescopio utilizzato nel 1655 e costruito dallo stesso scienziato olandese. Chasles avrebbe dovuto rendersi conto di essere la principale vittima di un enorme imbroglio.
Sempre a Le Verrier era giunta una memoria dello storico della Francia e saggista Henry Martin (1810-1883), il quale sosteneva che: a) certe lettere attribuite a Pascal e a Montesquieu, piene di anglicismi e costruzioni sintattiche sbagliate, erano l’opera di un falsario che sapeva male il francese; b) certe lettere attribuite a Galileo, scritte in francese da un italiano che doveva essere cieco, erano l’opera di un falsario che non conosceva la biografia di Galileo; c) i fatti contenuti in quei documenti e in altri della stessa collezione erano incompatibili con fatti incontestabili della storia dell’astronomia. Chi era allora il falsario? Brewster accusava Desmaizeaux, morto in esilio a Londra nel 1745, ma poteva esserci anche una mano inglese, o una mano più recente, che aveva continuato l’opera dei primi falsari. Non mancavano esempi nella storia di tali fabbricazioni su larga scala. Più tardi, quella collezione di bugie poteva essere passata nelle mani di un grande intellettuale che, in perfetta buona fede, l’aveva utilizzata per lo scopo onorevole della gloria della Francia.
Il 16 dicembre veniva letta una nota datata 30 novembre, giunta da Roma al segretario perpetuo da parte di Padre Angelo Secchi (1818-1878), gesuita, astronomo e pioniere dell’astrofisica. Poiché la polemica aveva toccato l’Italia, si sentiva in dovere di intervenire. Dalle ultime lettere di Chasles risultava che Viviani e Torricelli avevano aiutato Galileo a fare le osservazioni di cui egli stesso scriveva. Questo fatto era impossibile: Torricelli era giunto a Firenze nell’ottobre 1641 e rimase fino alla morte di Galileo, sopravvenuta l’8 gennaio 1642. In quel periodo Galileo era già completamente cieco, come testimoniava egli stesso in una lettera che fece scrivere nel marzo 1640 al Granduca Leopoldo di Toscana. (“mi è forza ricorrere all’aiuto degli occhi della penna di altri”). Galileo era completamente dipendente dall’aiuto dei suoi aiutanti e segretari. Inoltre, conoscendo il suo carattere, non avrebbe mai taciuto di una scoperta così importante come quella di un satellite di Saturno. D’altra parte era noto che nell’ultimo periodo della sua vita si occupava di meccanica e non di astronomia. Non bisognava fidarsi delle lettere presentate da Chasles, perché sapeva dell’abilità di certi falsari. Come astronomo, l’italiano intendeva, più che partecipare alla discussione, protestare contro questo tipo di imposture.
________________________________
Angelo Secchi (1818-1878) fu l’ultimo di una lunga serie di gesuiti scienziati che si formarono e operarono al Collegio Romano. Nacque a Reggio Emilia e frequentò il locale Collegio dei Gesuiti e, all’età di quindici anni, entrò in noviziato nella Compagnia di Gesù. Si distinse negli studi scientifici e, dopo aver insegnato Fisica a Roma e a Loreto, diventò assistente di Fisica al Collegio Romano.
A seguito della dispersione dei Gesuiti, Secchi lasciò l’Italia per recarsi prima in Inghilterra, poi negli Stati Uniti, presso il Georgetown College, a Washington. Il soggiorno americano fu molto importante per la sua formazione scientifica, perché gli permise di aggiornarsi sulle più moderne teorie riguardanti la fisica e la meteorologia dinamica.
Nel 1849 venne richiamato a Roma per assumere la direzione dell’Osservatorio del Collegio Romano. Convinto fautore dell’applicazione di nuove tecniche, fu tra i primi ad utilizzare la fotografia e la spettroscopia in campo astronomico, apportando importanti contributi nel campo della fisica solare e dell’astrofisica stellare.
Numerosi furono gli incarichi pubblici che Secchi svolse per conto del Governo Pontificio, tra cui la realizzazione della prima rete meteorologica italiana, la misura della base geodetica lungo la Via Appia Antica, il perfezionamento del sistema dei fari nei porti dello Stato Pontificio, le consulenze per la distribuzione delle acque potabili, per la collocazione dei parafulmini nei principali monumenti ed edifici pubblici, per l’installazione di ferrovie elettriche nello Stato Pontificio.
Partecipò alle spedizioni scientifiche che osservarono le eclissi totali di sole del 1860 e del 1870, in Spagna ed in Sicilia; nel 1869 collaborò con la Commissione geodetica italiana per la Misura del Meridiano Centrale Europeo e, negli anni 1870-72, prese parte ai lavori della Commissione internazionale per la definizione del Metro Standard. Nel 1867, con il suo meteorografo (la prima stazione automatica per il rilevamento dei dati meteorologici, da lui ideata) vinse il Grand Prix all’Exposition Universelle di Parigi e gli fu conferita la Légion d’Honneur.
Un importante aspetto della sua personalità fu il suo difficile ruolo di mediatore tra due culture, quella cattolica e quella laico-liberale, nel momento storico del durissimo scontro tra la Chiesa e il nuovo Stato dell’Italia risorgimentale. Negli anni successivi alla proclamazione di Roma capitale, Secchi si trovò a dover difendere il proprio Osservatorio dal rischio di confisca da parte dello Stato italiano, e dovette affrontare delle difficoltà economiche, che non gli consentirono di svolgere regolari programmi di ricerca. La sua salute, già malferma, ne fu fortemente minata e Secchi si spense per un male incurabile nel 1878, poco prima di avere compiuto i sessant’anni d’età.
________________________________
Interveniva Chasles, che intendeva rispondere a Martin, Harting, Secchi e Govi. Il suo lungo e puntiglioso intervento attaccava gli oppositori su alcuni punti del loro ragionamento, ma non intaccava la sostanza delle critiche. A Martin rispondeva che l’analisi dello stile era un argomento sul quale aveva già dato ampia risposta a Faugére; ad Harting rimproverava di non smentire alcunché di quanto era contenuto nella documentazione da lui presentata (Huygens migliorò le lenti avute da Galileo e scoprì la luna di Saturno indipendentemente da lui, poi chiese ai corrispondenti di non divulgare la scoperta); a Padre Secchi diceva di basarsi su una documentazione incompleta e su pregiudizi (Chasles poteva produrre due lettere, di Boilleau a Pascal e di Pascal a Fermat, in cui si parlava della testimonianza di Viviani su un Galileo ancora in grado di leggere e scrivere nell’ottobre 1641, ma impossibilitato a studiare gli astri e pertanto in attesa dell’arrivo di una persona abile come Torricelli); a Govi rimproverava di non sapere che molte lettere di Galileo non portavano l’indicazione del luogo (non tutte quindi erano datate a Firenze) e che lo scienziato italiano corrispondeva in francese con molti personaggi importanti, da re Luigi XIII a Richelieu, da Gassendi a Cartesio (Chasles possedeva naturalmente le prove).
Il 23 dicembre prendeva la parola il presidente Balard per lamentare che il tono degli interventi sui documenti presentati da Chasles stava diventando troppo acceso e sottolineava che solo grazie alla cortesia di quest’ultimo era stata messa agli atti la lettera di Padre Secchi contenente gravi insinuazioni sul suo conto. La disponibilità di Chasles a mostrare, inviare in copia o in fotografia i suoi documenti testimoniava la sua onestà, che poteva essere discussa solo da chi non lo conosceva. Si augurava poi che Chasles pubblicasse al più presto la sua intera collezione affinché il dibattito non fosse limitato a un circolo ristretto. Nel frattempo non avrebbe più inserito nuovi documenti tra i resoconti dell’Accademia.
Le Verrier commentava che la decisione di censurare d’autorità i nuovi documenti era criticabile, anche se, per evitare polemiche, egli stesso invitava membri e corrispondenti a intervenire e presentare memorie solamente se esisteva qualcosa di nuovo da far conoscere. Dopo una discussione alla quale prendevano parte alcuni dei presenti, la proposta di Balard, messa ai voti, veniva respinta.
Alla fine del 1867 i sostenitori di Chasles ricevono un sostegno inaspettato nella persona di Adolphe Thiers. Storico, membro dell’Accademia di Francia e statista – quattro anni dopo sarà presidente della Repubblica – Thiers è una figura di spicco. Una sera a Parigi, nel popolare salotto letterario della principessa Giulia Bonaparte, frequentato tra gli altri da Ernest Renan, Sainte-Beuve e Barbey d’Aurevilly, si parla della polemica che scuote l’Accademia delle Scienze e qualcuno fa accenno alla credulità di Michel Chasles. Thiers si lascia trasportare e ribatte: “Siamo francesi sì o no? Se lo siamo ancora, è vergognoso osare mettere in dubbio l’autenticità di questi documenti che dimostrano inconfutabilmente che Newton è stato solo un plagio del nostro grande Pascal!” Si sostiene che ci sia voluta tutta la squisita diplomazia della principessa Bonaparte per riportare la calma nel salone. Tra le cause del propagarsi epidemico delle bufale Bloch avrebbe forse dovuto mettere in evidenza il nazionalismo. Del resto, nella memoria letta da Vrain Lucas durante il processo a suo carico, dirà di aver voluto restituire alla Francia la gloria usurpata dagli stranieri.
Marco Fulvio Barozzi